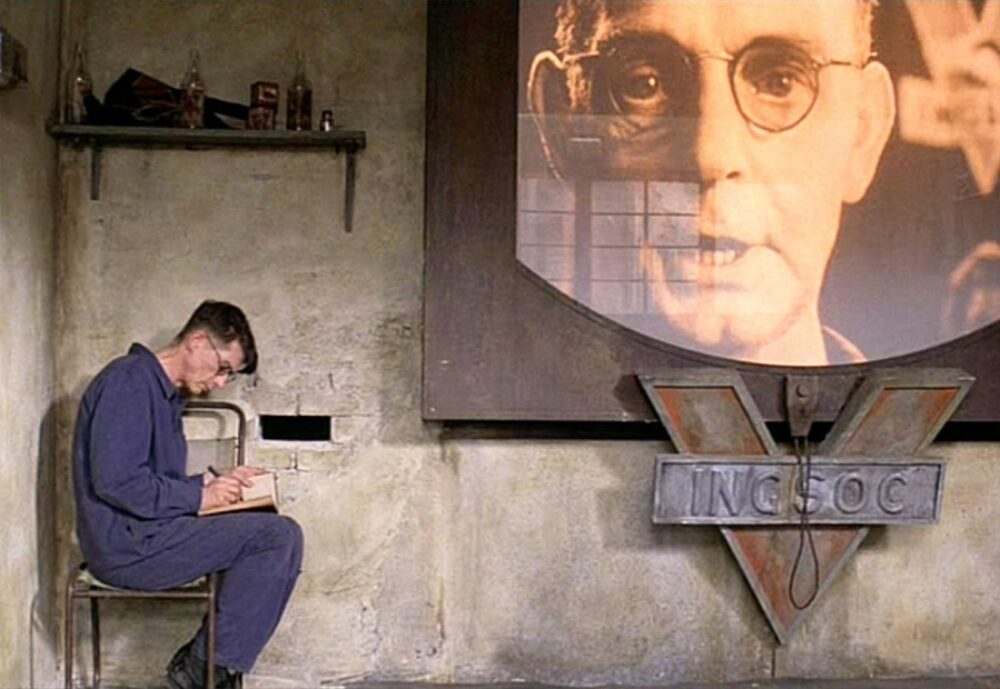Pierina, mia nonna, di guerre mondiali se ne intendeva. Le aveva vissute tutte e due, infatti, lei che aveva sempre abitato in un piccolo paese appiccicato a un confine. A me e agli altri nipoti raccontava, talvolta confondendo una guerra con l’altra, dei bombardamenti, del razionamento, del continuo andirivieni di soldati. Prima a cavallo, poi coi camion e i carri armati. Ma soprattutto amava raccontare una storia in particolare, quella del bel tenente. La narrava spesso, come gli anziani che quando perdono la capacità di trattenere il presente, si rifugiano in un passato in cui immagini in bianco e nero ormai sbiadite assumono colori più brillanti, si riempiono di dettagli. E infatti, ogni volta, la storia del bel tenente si arricchiva di particolari, di episodi inediti, di nuovi personaggi. La seconda guerra mondiale era ormai alla fine, era arrivato l’autunno del 44, raccontava Pierina, e i tedeschi in ritirata dal sud si erano accampati proprio qui, dove adesso c’è tutta questa campagna. Avevano piantato le tende per i soldati vicino al ponte sul torrente, mentre gli ufficiali si erano presi la scuola elementare, quella che adesso non c’è più. I ragazzi prendono lo scuolabus e vanno a studiare in città. I tedeschi non erano così cattivi come ci avevano detto, sai? Se ne stavano tranquilli per conto loro, non davano fastidio a nessuno. Anzi, quando preparavano il rancio per la truppa, a mezzogiorno e alla sera, ne davano anche a tutti i bambini del paese, bastava presentarsi con una scodella. E se era finita la zuppa, ti davano del pane. Gli ufficiali, invece, mangiavano ogni giorno alla trattoria dell’Antonio. Quella c’è ancora, adesso la manda avanti il nipote, quello che fa le pizze. Ed è proprio lì che il tenente, io non conosco i gradi, me l’ha detto mio fratello che era un tenente, ha conosciuto la Maria.
Lui era davvero bello. Alto, biondo, con quella divisa nera sembrava proprio un attore del cinema. Perché al cinema ci andavo, cosa credi? Tutte le domeniche in parrocchia Don Luigi ci faceva vedere una pellicola che si faceva mandare dal vescovo. Ogni volta che c’era una scena d’amore, magari due che si baciavano, lui metteva la mano davanti al proiettore e recitava una preghiera. A noi veniva da ridere, Don Luigi lo sapeva, andavamo tutte a confessarci da lui, che capivamo benissimo cosa stava succedendo. Ma dopotutto era un bravo prete, ci dava sempre l’assoluzione. Il tenente era bello, bellissimo, ti dicevo, ma la Maria era ancora più bella di lui. Non aveva ancora vent’anni e tutti se la mangiavano con gli occhi, quando si fermavano all’osteria a bere un bicchiere di vino. Ma lei non dava confidenza a nessuno, era troppo seria. Suo padre era morto qualche anno prima, in Africa, quando c’era la guerra col Negus, lei era tanto piccola, poverina… Ma sì, il Negus, quello che comandava tutti quegli schiavi in Africa, quello lì. La Maria viveva con la mamma, proprio nella casa qui vicino, quella dove abita adesso il falegname, il Silvano. Insomma, quei due, appena si sono visti, apriti cielo! La Maria era sempre accanto al suo tavolo, a costo di trascurare tutti gli altri clienti. Quante volte doveva richiamarla l’Antonio! Vuole il pollo, signor tenente? Le piace questo vino, signor tenente? Davvero non vuole il caffè, signor tenente? Perché lui l’italiano lo parlava. Lo parlava bene per essere un tedesco. La moglie dell’Antonio, che vendeva il sale e i tabacchi, sempre dietro al banco solo per impicciarsi dei fatti di tutti, diceva che il tenente, prima della guerra, faceva il maestro di scuola a Berlino. Che era un’appassionato d’arte, che sapeva più cose lui del nostro, di maestro. Alla Maria, il tenente faceva un sacco di domande, la voleva sempre intorno. Le raccontava anche di casa sua, della Germania. E di tutte le città che aveva visto in Italia, durante quella lunga ritirata. Di tutto quello che era andato perduto sotto i bombardamenti. Tutti i giorni così, con il tenente che veniva in trattoria sempre più spesso, “un caffè, Maria, per favore!” e lei, lei che sembrava fosse lì solo per vederlo. Una sera lui l’ha aspettata fuori dall’osteria, dopo la chiusura. La moglie dell’Antonio, sempre quella chiacchierona, l’ha visto arrossire, quando ha chiesto alla Maria se poteva accompagnarla a casa. Era imbarazzato, il tenente. Comandava duecento uomini, la medaglia di Stalingrado al collo, ma davanti alla Maria, da solo, sembrava avere paura. Lei non ha detto nulla, ha solo annuito, allora lui l’ha presa a braccetto e si sono incamminati. Chi li ha visti quella sera il giorno dopo ha raccontato che parlava solo lui, mentre si faceva condurre per le strade del paese. Maria sorrideva solo ogni tanto, improvvisamente timida. Ma c’era anche chi diceva che un giro così lungo, per andare dall’osteria a casa della Maria, non si era mai visto. Lui non è entrato, anche se la madre ha insistito tanto. Dopotutto i tedeschi, anche se sembravano buoni, erano i padroni del paese e lui era il capo dei tedeschi. No, ha salutato tutte e due le donne e se è andato. Il giorno dopo non si parlava d’altro, naturalmente. Al tedesco piace la Maria! Il tedesco si è innamorato di Maria! I primi a chiacchierare di questa cosa erano quelli che si definivano partigiani, anche se in realtà più che ascoltare la radio di nascosto non facevano. Che ripetevano di continuo che i tedeschi erano il nemico, che non bisognava assolutamente avere rapporti con loro. Male faceva Maria a dare confidenza all’ufficiale. Ma la verità è che erano tutti gelosi, quei pochi uomini che, per un motivo o per l’altro, avevano scansato la chiamata alle armi. La Maria era una del paese, una di noi, mica poteva arrivare uno dalla Germania e portarsela via. Ma lui, che ne sapeva? Era solo un ragazzo, dopotutto, proprio come i nostri, anche se portava quella divisa. Se non ci fosse stata questa maledetta guerra, il tenente, anzi il maestro, a Berlino avrebbe corteggiato un’altra ragazza, bella come Maria. Ma lui era qui, adesso. E qui c’era Maria, che altro poteva fare? Non c’è colpa nell’essere giovani, come lo ero io allora. Lo sapeva anche Don Luigi, il prete. Quello delle penitenze piccole. La sera dopo la passeggiata era diventata ancora più lunga, così lunga che era buio quando Maria era rientrata a casa. E al buio, io e le mie amiche ne eravamo sicure, era successo quello che in parrocchia si nascondeva con una mano davanti al proiettore. Il tenente ama Maria!
E poi è arrivata la festa del paese, la festa della nostra santa. Tu lo sai che il paese ha preso il nome da una santa che…? Sì, va bene, non c’entra adesso, volevo solo spiegarti. Guerra o non guerra, la festa noi l’abbiamo fatta, come tutti gli anni. In piazza, a sentire la banda, c’eravamo tutti. Con quel vestito rosso che si era cucito da sola, Maria era più bella che mai, ma nessuno, proprio nessuno, la invitava a ballare. Tutte noi eravamo sempre in pista con l’uno o con l’altro, lei no. E allora ci ha pensato lui. E’ arrivato, sempre perfetto in quella divisa nera, e l’ha presa. Che coppia! E come la teneva stretta! Sembravano volare intorno alla piazza, mentre tutte le altre coppie si fermavano per guardarli. Quando la banda ha smesso di suonare sono rimasti soli, in mezzo alla piazza. Sciolti dall’abbraccio, l’uno di fronte all’altro. Nessuno parlava più, eravamo tutti ammutoliti. Poi, ancora lontano, il rombo degli aerei alleati che venivano a bombardare la ferrovia, la festa era finita.
Ma adesso qualcosa era cambiato, non potevamo più far finta di nulla. Non era più solo lui, il tenente, il problema. C’era dell’altro. E non bastavano più nemmeno le chiacchiere, i commenti maliziosi a mezza voce, quando lui, ormai ogni sera, la andava a prendere all’osteria. Una mattina, proprio sulla porta di casa sua, Maria aveva trovato scritte delle brutte parole. E per strada, nessuno più salutava né lei né sua madre. Che il tenente fosse innamorato di Maria, poteva anche andare. Dopotutto mica era colpa di Maria se lui le faceva la corte. Ma che anche lei fosse innamorata, questo proprio no. Questo era lo scandalo.
Alla fine dell’autunno i tedeschi se ne sono andati. Gli inglesi, così avevamo saputo, avevano sfondato le linee più est, il tenente e il suo reparto dovevano correre in aiuto. Me lo ricordo quel giorno, quando sono partiti. Lui in testa alla colonna, sul carro armato. La Maria sulla strada, a guardarlo andare via. In silenzio, come dopo quel ballo. Qualche giorno dopo sono arrivati gli altri, divisa diversa, lingua diversa, ma sempre soldati. Si sono accampati nello stesso posto, facevano le stesse cose. Però per la Maria le cose si sono fatte difficili. Adesso che non c’era più lui, adesso che non c’erano più i tedeschi, quelli che prima le parlavano solo dietro le spalle, quando entravano all’osteria la trattavano male, la insultavano. Più di una volta l’Antonio, che è sempre stato una brava persona, peccato che ha sposato quella pettegola, è dovuto intervenire per difenderla. Quando non ce l’ha fatta più a sopportare gli insulti, le cattive parole, le minacce, la Maria ha preso su sua madre e se è andata. Qualcuno diceva a Mantova, altri a Milano. Quando la guerra è finita se sono andati via anche gli altri, gli inglesi. E tutto qui ha ricominciato a funzionare come prima.
Ma lui, lui, il tenente, è tornato. Quattro, cinque anni dopo, è tornato. Qui, in paese. In borghese faceva un altro effetto, ma era sempre bello. Cercava la Maria, ma non sapevamo dirgli dove era andata. Non sapevamo nulla. Si è fermato una settimana, il tenente. All’osteria raccontava che faceva di nuovo il maestro, adesso insegnava l’italiano in qualche scuola, a Berlino. Continuava a chiedere di lei non si dava pace. Quando è ripartito ci siamo accorti che gli volevamo tutti bene, anche quelli che allora l’avrebbero ammazzato volentieri, quel crucco cosi gentile. E’ salito sulla sua piccola Volkswagen ed è tornato a casa, in Germania. Povero tenente… Perché mi guardi così? E’ tutto vero, sai? Sono vecchia, non rimbambita!