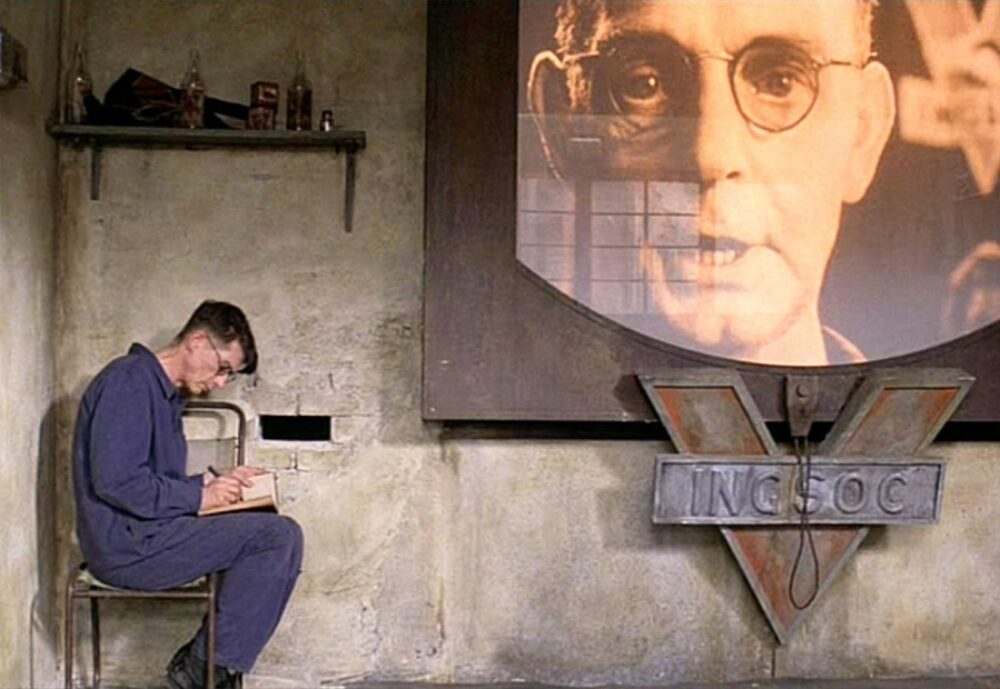Sai, credo che le città abbiano una memoria. Noi forse abbiamo dimenticato, ma loro ricordano i nostri visi, le nostre parole, i passi consumati in tutte le vie. Tornare qui, allora, è cercare ad ogni angolo quello che eravamo, cercare di rivedersi, di rivederti. C’eravamo arrivati, questo non puoi averlo scordato, ne sono sicuro, con un treno davvero troppo lento per tutti i chilometri che ci aspettavano. Un treno su cui avevamo trovato posto a fatica, con i nostri zaini in spalla e i nostri vent’anni ancora tutti da spendere. Allora c’erano ancora le frontiere e doganieri seri e compunti. Ansiosi di esaminare passaporti e bagagli, non sia mai che potessero contenere cose vietate. Vietate in quel paese che, giusto proprio allora usciva da un economia programmata da piani quinquennali e dalle code ai negozi. A noi non hanno chiesto nulla, però. Era chiaro persino a loro che l’unica cosa che potevamo contrabbandare era solo la nostra voglia di stare insieme, noi e solo noi.
Siamo arrivati che era ormai notte, notte in una città a noi sconosciuta, ancora. Il cambia valuta, banconote colorate di cui ancora non conoscevamo il valore, un panino, il taxi. E la casa che avevamo affittato, fidandoci della parola di un amico. Non così bella come ce l’eravamo immaginata, troppo piccola, troppo distante dal centro. Tu non hai voluto dormire, in quel grande letto di legno che occupava praticamente tutto l’appartamento. Ci siamo distesi vicini, sul pavimento, sui sacchi a pelo che ci eravamo portati per ogni evenienza. E poi il sonno, fino al mattino.
E il giorno dopo, appunto, alla ricerca di una nuova sistemazione, ancora con gli zaini sulle spalle. Fu un tassista, a darci la dritta giusta, inviandoci da una signora che lui chiamava zia. Che probabilmente non era nemmeno sua parente, ma che ci mise subito a disposizione tre piccole stanze nella città vecchia. Tu ne eri entusiasta, ricordo. Di quei mobili laccati azzurri, forse lì ancora dagli anni 50, dai ritratti di soldati e tranvieri appesi al muro, delle due finestre che si aprivano sulla piazza. La città, adesso, era veramente nostra. Non mi ero preparato un granché, su quello che avremmo dovuto vedere, visitare. Del resto non c’era bisogno di cercare, di leggere guide, di chiedere. Ogni via, ogni angolo sembrava avere un segreto da scoprire, meritava una sosta, parole tra di noi. Le scritte dei negozi, così difficili da decifrare, tanto che non riuscivamo a capire cosa fosse realmente in vendita. Le birrerie, con i piccoli tavoli sulla via, dove raramente tu trovavi qualcosa che ti piacesse, mentre io mi rimpinzavo ogni volta. E le librerie, i dischi di musica classica così a buon mercato, le pasticcerie, i mercati, i tram con i manovratori in divisa, i musicisti di strada.
Eri felice. Come una bambina correvi sempre avanti, mi prendevi per mano, mi trascinavi. Guarda questo, dai andiamo a vedere quello, corri dai! Io ti seguivo, senza capire che quello che veramente ti faceva sorridere, ti faceva fare tutti quei discorsi, ti illuminava, eravamo noi. Che cominciavamo a conoscerci. Tu ed io, che giravamo senza meta, senza nessuna pretesa, se non quella di guardare insieme tutto quello che ci stava intorno. Abbiamo visto cattedrali dove sono stati incoronati imperatori, quadri di pittori che hanno attraversato e superato i secoli, statue e mausolei di eroi, orologi che mostravano il cammino delle stelle. Ma nulla di tutto questo valeva, poteva valere, le nostre sere. Quando tu ed io guardavamo quella che era diventata la nostra città da una finestra. Quando anch’io, finalmente, riuscivo a capirti, a capire noi. Non non avrei voluto mai andare via, avrei voluto, invece, ogni sera, ritrovarci qui. Per sentirti raccontare, per raccontare anch’io.
Questa città, la nostra città, sai, è cambiata. Le librerie, adesso, sono diventate fast food, negozi high tech. Le insegne sono ora in inglese, e le code le puoi trovare solo fuori dal caffè che frequentava Kafka. La sinagoga è ancora lì, ma vicino stanno costruendo un centro commerciale. E poi casinò, gelaterie, ristoranti italiani, moda in franchising, sexy shop. Non la riconosceresti più. Ma io continuo a pensare che da qualche parte, in qualche via, in qualche angolo, proprio lì, noi stiamo ancora chiacchierando