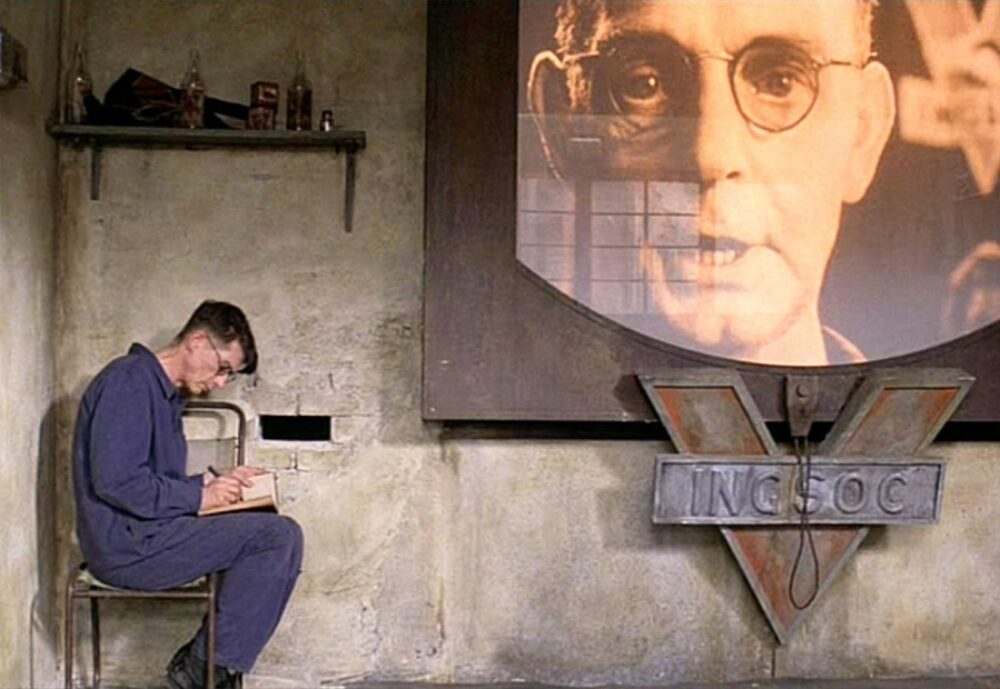Racconta mia figlia che, proprio ieri, un signore con la pelle un po’ più scura della sua, un signore nato in Africa, è andato a fare visita alla sua scuola. Racconta mia figlia che è entrato nella sua classe e si è seduto alla cattedra, al posto del prof. E racconta mia figlia che anche il signore aveva una storia da narrare, la sua. Della sua fuga da un posto dove la vita era molto, troppo difficile, dove avevano già ucciso suo padre. Racconta mia figlia che insieme alla madre e alle due sorelle più piccole, il signore ha intrapreso un lungo viaggio, che lo ha portato fino alle coste del Mediterraneo, in un paese chiamato Libia. Dove tante altre persone come loro, che cercavano di fuggire da un destino troppo gramo, attendevano l’occasione. Una piccola imbarcazione a malapena in grado di stare a galla, che li avrebbe portati via. Ma attendere il proprio turno, racconta mia figlia, non era cosa facile. Quasi nulla da mangiare, bande di disperati pronti a derubarti di quel poco che ti era rimasto, agenti di polizia dal manganello facile sempre disposti a picchiare qualcuno. L’attesa è durata a lungo, racconta mia figlia. Una volta sembrava quasi fatta, sembrava ci fosse posto anche per loro, su un gommone. Ma sono stati rimandati indietro. Ancora botte, furti, sopraffazioni. E giorni, settimane, mesi. Cercando di sopravvivere, in quel campo di fuggiaschi. Racconta mia figlia che quando finalmente era arrivato, questa volta era vero, il giorno della partenza, la famiglia aveva dovuto separarsi. La madre si era imbarcata con le sorelle più piccole su un imbarcazione, lui su un altra. Era l’ultima possibilità, non si poteva rinunciare. Racconta mia figlia che la madre, prima di separarsi da lui, gli aveva regalato tre caramelle, un tesoro, visto che nel loro paese natale, riceverne in dono una era già gran festa. E gli aveva detto di tenerle bene in serbo. Se si fosse trovato in difficoltà , avrebbe potuto mangiarne una e ricordare così quelle rare occasioni di festa, le sue sorelle, sua madre. Il viaggio era cominciato di notte, il mare era agitato, faceva quasi freddo. Stipato sul gommone, racconta mia figlia, racconta mia figlia, le mani in tasca a tenere nel pugno stretto stretto, quei tre pezzettini di zucchero, quello che sperava fosse il suo ultimo viaggio, era cominciato. La mattina dopo, quando il mare si era ancor più incattivito, aveva cominciato ad avere paura. Per sé e per la sua famiglia, l’altro gommone non si vedeva più, ma forse aveva solo preso un’altra rotta, Dio avrebbe pensato a tutti quanti. Racconta mia figlia che fu raccolto la sera, da una nave grande, tutta rossa. Che dopo poche ore lo aveva sbarcato in Italia. Poi il centro di accoglienza, le prime cure, parole in una lingua a lui straniera. E racconta mia figlia, la ricerca, il passaparola, avete visto una donna con due figlie? Erano sull’altro gommone, avete trovato anche loro? Telefonate, cartelli, se qualcuno le ha viste, le ha incontrate, mi avvisi, mi chiami, io aspetto. Racconta mia figlia che è stato tutto inutile. Nessuno aveva visto quella donna, le sue bambine. Lui intanto aveva trovato posto in una parrocchia, dava una mano un po’ a tutti, stava imparando a parlare l’italiano E poi un lavoro vero, la scuola serale. Ma non aveva smesso di chiedere, ad ogni connazionale, a chi arrivava, come lui, dall’altra parte del mare, di sua madre delle sue sorelle. Racconta mia figlia che lui , anche se non l’ha detto, non smetterà mai. E che alla fine della sua storia, in un silenzio di ghiaccio, prima di uscire dall’aula ha messo una mano in tasca e ne ha tirato fuori qualcosa. Tre caramelle.
Tag Archives: scuola
Lorenza
Lorenza. Lei dice L’orrenda, ma non è mica vero. Si veste solo in modo un po’ strano, diverso da quello delle altre due sorelle. Una più grande, l’altra più piccola. E stare in mezzo, si sa, è complicato. Ci sono gerarchie da rispettare, turni, spazi. Un delicato equilibrio da mantenere, complicato anche dalla specificità femminina. I maschi sono più semplici, più diretti. Male che vada, una bella scazzottata, un lancio di figurine, soldatini di plastica e carri armati in scala, risolvono il problema Poi, ricominciamo come se nulla fosse accaduto. Ma stavamo parlando d’altro. Lorenza è bella, appunto. Anche le altre sue sorelle sono belle, naturalmente, ma non come lei. Sfruttando un cliché ormai piuttosto logoro, potremo dire che lei ha qualcosa in più. Ma quel qualcosa non sai dire cos’è, non sai dargli un nome Però c’è. Tanto che, per capirne di più, sei obbligato a inseguirla ogni giorno sul treno che porta tutti a scuola. No, non la medesima scuola, appena arrivati in città, la fiumana di zaini e cartelle, si divide. Ognuno raggiunge il suo istituto. Geometri, ragionieri, periti meccanici, maestri e persino cuochi. Ma, finché non arriva a destinazione, il treno mescola tutti. E rende possibile, anche per chi frequenta corsi professionali per elettricisti ed estetiste, dove il sesso unico domina, l’incontro, lo scambio, la parola. Dura poco, il viaggio, bisogna sbrigarsi. Dove è salita? Quante carrozze bisogna percorrere? E senza farsi notare, ovvio. Che deve sembrare tutto un caso. Dribblare i colleghi del calcio all’oratorio, le amiche di tua sorella. Buongiorno, come va oggi? Non sei nemmeno l’unico, ad inseguire, ma questo lo sai già. Ti devi misurare con altri, è la regola. No, non ci si picchia, non si lotta. Si inventa, piuttosto, si racconta. Di serate favolose, passate in un locale, dove, in realtà, non sei mai stato. Di dischi rari, gruppi quasi sconosciuti, ma che di sicuro avrebbero fatto la storia del rock, del pop, o di qualsiasi altro genere. Cerchi di stupire, di renderti interessante, di essere, dopotutto, migliore. Anzi, più figo. Io, allora, non sapevo inventare, raccontare. Non ero ancora quel bugiardo seriale, il mentitore che sono ora. Sapevo parlare solo di libri che leggevo tutte le notti, altro che la sbronza nel pub irlandese o ballare fino all’alba nell’unica discoteca che poteva offrirci la città. Non ero interessante, non ero perspicuo, ero in ritardo per quegli anni, e forse in anticipo per quelli che sarebbero venuti dopo. Andavo avanti e indietro, di più non potevo. Sapevo solo sognare. Come ora, forse. Solo che adesso ho trovato le parole che allora, davvero, mi mancavano.
Basta, ti prego
Irene l’aveva conosciuta alle superiori. Già il primo giorno, quando frastornato da quella novità, in ritardo sull’entrata in classe, aveva preso l’ultimo posto libero. Proprio quello accanto a lei. Che aveva fatto finta di non vederlo, tutta compunta ad ascoltare qualcuno che, dalla cattedra, augurava a tutti il migliore degli inizi. Cosa ci faceva lì, proprio in quella scuola, ancora non lo sapeva. Figlio purtroppo unico di due genitori assenti e troppo protettivi allo stesso tempo, non aveva mai scelto nulla. Tutto era sempre stato selezionato e approvato da loro. Lo strumento che aveva imparato a suonare a fatica, la squadretta di calcio da seguire, quasi sempre in panchina, tutte le domeniche. I compagni di scuola che poteva frequentare, gli amici che poteva invitare a casa. Naturale che, alla fine, scegliessero anche il suo futuro, cosa di cui lui aveva imparato a non preoccuparsi più. Ci avrebbe pensato qualcun altro a dirgli cosa fare.
Qualche parola avevano cominciata a scambiarla solo dopo qualche settimana, Ed era stata lei a prendere l’iniziativa, lui era fin troppo timido. Quando Irene lo guardava lui si sentiva un po’ a disagio. Era tanto diversa dalle ragazzine che aveva conosciuto, sempre col permesso dei genitori s’intende, alle medie. Non era un gran bellezza certo, del resto nessuno dei suoi compagni di classe sembrava avere mire su di lei. Ma aveva un piglio e un modo di fare che in qualche modo lo affascinavano. Sembrava sempre sicura di sè, aveva sempre la risposta pronta. E lo guardava in quel modo… Alle sue proposte, era già arrivata l’estate, di trovarsi dopo le lezioni per studiare insieme, lui aveva inizialmente opposto mille scuse. Ho da fare, oggi non posso, ho già un impegno con degli amici. Ma, alla fine, l’aveva avuta vinta lei. E qualche volta a casa sua, qualche altra volta a casa di lei, si erano ritrovati a sfogliare libri e a parlare d’altro. Ai suoi, comunque, qualche spiegazione aveva dovuto darla. Chi è, chi non è. Studiamo insieme, diceva lui, è una compagna di classe. Ma se a sua madre questo bastava, c’era qualcosa che gli sfuggiva. Qualcosa che non riusciva a capire.
Si erano ritrovati dopo l’estate. Lui aveva fatto le consuete due settimane al mare con i suoi e poi aveva passato il resto del tempo ad annoiarsi. Irene, piuttosto, raccontava del suo viaggio in Inghilterra, del corso estivo, dei ragazzi e delle ragazze che aveva conosciuto. E lui, che si fingeva interessato, sentiva dentro di se qualcosa che non aveva mai provato. Aveva pensato a lei tutta l’estate, anche se non aveva mai trovato il coraggio di chiamarla. Irene sembrava invece non aver sentito la sua mancanza, forse si era dimenticata di lui per tutto quel tempo. La scuola era ricominciata e ancora si ritrovavano per studiare, per lavorare insieme. E poi, i suoi genitori avevano insistito tanto, l’aveva invitata fuori, un panino e poi al cinema, dai. Si sentiva imbarazzato proprio come quella volta che si era seduto nel banco vicino al suo. Avevano mangiato quasi in silenzio nel fast food strapieno di gente e poi, al cinema, era rimasto seduto tutto il tempo con gli occhi fissi sullo schermo. Erano rientrati abbastanza presto, lei l’aveva ringraziato della serata e a lui era bastato. Non sapeva bene cosa aspettarsi, non sapeva bene cosa si aspettasse lei. Dopo qualche settimana erano usciti ancora, stavolta toccava a lei invitarlo, e lui si era sentito più a suo agio. Avevano scherzato, preso in giro professori e compagni di classe, parlato della sua ex squadra di calcio e dei cantanti che piacevano a lei. Stavolta era stato lui a ringraziare, timidamente come sempre. Lei gli aveva dato un bacio sulla guancia.
Era tornata ancora l’estate. Ancora le vacanza coi genitori, solito posto, solito mare. I suoi tentativi di convincerli a trovare una soluzione diversa, quando gli sarebbe piaciuto un viaggio di studio come quelli che faceva Irene, erano stati inutili. A niente erano valse le sue proteste, ma insomma ho sedici anni, non posso sempre venirvi dietro. Così si faceva, così si sarebbe fatto. Mesi di noia poi, ad aspettare che la scuola ricominciasse. L’aveva cercata però, e una volta era riuscito persino a sentirla al telefono. Lei era ancora in Inghilterra, non a Londra ma in qualche posto del nord. E stava bene, gli aveva detto, era tutto ok. Lui non sapeva se esserne contento, forse avrebbe voluto sentire che gli mancava un poco, che aveva voglia di vederlo. Quanta ne aveva lui di vedere lei. Si erano rivisti proprio un paio di giorni prima che iniziasse la scuola, appuntamento proprio sotto casa sua. L’aveva attesa per quasi un ora, era uscito in anticipo, sperando che anche lei facesse lo stesso. Era arrivata puntuale invece, con i capelli più lunghi e un ombra di trucco, proprio lei, che non l’aveva mai fatto. Avevano passeggiato verso il centro, mentre si faceva sera. Lui gli aveva proposto di mangiare qualcosa, lei aveva accettato. Il solito panino o, meglio, una pizza. A tavola l’aveva quasi stordito coi suoi racconti, era contenta, si vedeva. Ma non una parola su di lui, su di loro. E non aveva il coraggio di chiederglielo, di dirglielo, ti sono mancato, mi sei mancato. Solo storie di quell’Inghilterra che lui non aveva ancora visto. Non sono interessante come lei pensava. E forse non sono interessante come altri che ha conosciuto questa estate. Dopotutto, che ho da raccontare io? Erano usciti tardi, dalla pizzeria ma aveva voluto offrirgli un gelato, sulle panchine del piccolo parco. Lei continuava a parlare, di quello che avrebbe voluto fare ancora quest’anno e poi quello prossimo. Ne era sicuro, non ci sarebbe stato più posto per lui. Che non poteva seguirla, che non aveva mai niente da dire, se non le poche cose di ogni giorno. Che non sarebbe mai stato come lei, che non avrebbe mai combinato nulla. Le mani intorno al collo gliele aveva strette senza volere, o forse perché pensava dentro di sè che quello era l’unico modo per fermarla, per non lasciarla andare via. E mentre lei cercava di divincolarsi, senza più respiro, lui continuava a sussurrarle:”Basta, ti prego. Basta.”
Testa o croce
Non gliela aveva data l’assoluzione, il prete. Peggio ancora, non aveva nemmeno voluto darle uno straccio di consiglio. Intendiamoci, non che Teresa si aspettasse molto da un prete, soprattutto da un prete del nord, ma la zia Carolina aveva insistito tanto e lei non aveva voluto deluderla. La zia Carolina, la moglie di Antonio, il fratello di papà. Arrivata a Milano per quella supplenza, era andata a stare a casa loro. E non ci stava male. Antonio, venuto su tanti anni prima per lavorare all’Alfa Romeo, si era trovato quella moglie milanese, forse un po’ troppo su di tono per lui, ex bracciante diventato prima operaio e poi addirittura caposquadra. Aveva fatto carriera, certo, e ora, pensionato e benestante, si godeva la sua non troppo avanzata vecchiaia. Da loro si stava bene, appunto, lontano dal paese e dalla vicinanza ingombrante dei cinque fratelli, tutti in attesa di una moglie dei paesi tuoi. E tutti sempre preoccupati per la sua sorte. Sua e del suo fidanzato, Vincenzo. Il povero Vincenzo, anzi. Compagno di scuola del maggiore dei fratelli e di fatto quasi costretto a fidanzarsi con lei. Sei nostro amico, fai parte della nostra famiglia, guarda quanto è carina Teresa. Sarebbe bello se diventassimo davvero parenti, non ti pare? E Vincenzo, buono come il pane, si era piegato a quel ricatto. Ogni domenica la veniva a prendere. Prima il cinema, naturalmente accompagnati da Gaetano il più piccolo, non si sa mai che nel buio della sala cinematografica non succedessero cose che non stanno bene, poi un gelato. Vincenzo, che era venuta a salutarla alla stazione quando, appena diplomata, l’avevano chiamata per quella lunga supplenza a Milano. L’aveva baciata su una guancia, guardato a vista da tutti e cinque i fratelli. In famiglia non è che fossero proprio contenti, si capisce. Sui giornali, quelli che si leggono al paese, c’era scritto che Milano è davvero una città dove succede di tutto. Grande e pericolosa. Dove una ragazza per bene deve stare molto attenta. Ma poi lo zio Antonio e la zia Carolina si erano offerti di ospitarla, e anche la mamma si era messa in cuore in pace. Teresa aveva presto scoperto che Milano non era proprio quella che si leggeva sui giornali. Sì, grande, tanta gente, tanta confusione, quello sì. Ma c’era anche dell’altro. E quello glielo aveva fatto scoprire Michele. L’aveva conosciuto a scuola, era il maestro dell’altra quinta, quella nell’aula di fronte alla sua. Era stato gentile con lei fin dai primi giorni, quando davvero avrebbe voluto scappare via. Da quei ragazzi fin troppo vivaci, da quei genitori pieni di sussiego. Che, prima di informarsi sul rendimento scolastico dei loro figli, le chiedevano da dove veniva. A Michele questo non interessava, la chiamava Teresa, anziché maestra Castiello, e le aveva fatto scoprire un altra città. Quella delle osterie di periferia dove si poteva mangiare con qualche spicciolo e quella dei locali del centro per l’aperitivo più elegante. I cinema di prima visione, i teatri, i concerti. Lo zio Antonio, naturalmente, non aveva visto di buon occhio, fin dal primo momento, quell’amicizia. Ma Carolina, dopo aver conosciuto Michele una domenica sera, quando lui aveva riaccompagnato Teresa a casa ed era stato invitato a salire per un caffè, ne era stata letteralmente conquistata. E le proteste del consorte, da quel momento, avevano avuto ben poco pregio. Lasciala stare che quello è un bravo ragazzo, Antonio. Vai a giocare al lotto che non si sa mai. E i mesi erano passati, uno dopo l’altro. Con Vincenzo che telefonava tutte le settimane, di giovedì, era molto preciso, e quello che Michele le faceva scoprire ogni giorno. Fino a Sant’Ambrogio, quando era successo quello che Teresa forse aspettava senza avere il coraggio nemmeno di sperarlo. Quando Michele, davanti alla porta della casa degli zii, l’aveva baciata. Un bacio vero. Mica come quelli di Vincenzo, quelli dati solo con l’assenso dei fratelli. Rapidi e senza sapore. Teresa, naturalmente, aveva raccontato tutto alla zia. Che, da donna di mondo, non aveva preso posizione, anche se sotto sotto si vedeva che faceva il tifo per Michele. Sei tu che devi decidere, io non posso dirti niente. Pensaci bene. Poi l’aveva mandata dal prete, quel Don Mario che tutte le domeniche, dal pulpito, predicava così bene da sembrare quasi un attore. Ma nemmeno lui le aveva detto cosa doveva fare. Le aveva evitato, però, le solite tiritere sul peccato e sulle promesse tradite. A Milano anche i preti si sono adeguati. Succede di tutto, in questa città, succede anche questo. Giudicare a che serve? E Teresa, davvero, si era sentita persa. Anzi, divisa. Tra due uomini, sì, sebbene uno, da tempo, non fosse niente di più che una voce al telefono. Da ascoltare con pazienza, non ha mai nulla da raccontare. Ma anche tra due famiglie. Quei fratelli così preoccupati del suo futuro, tanto preoccupati da organizzargliene uno, e la zia così diversa. Che forse aveva già capito tutto prima di lei. E fra due città. Se città poteva chiamarsi il paesino dove mamma e papà raccontano con orgoglio di avere una figlia che insegna a Milano. Teresa non sa. Ma stasera lui verrà a prenderla. E allora, se quello che è successo domenica non era un gioco, lei capirà. Si trucca, sono già le otto