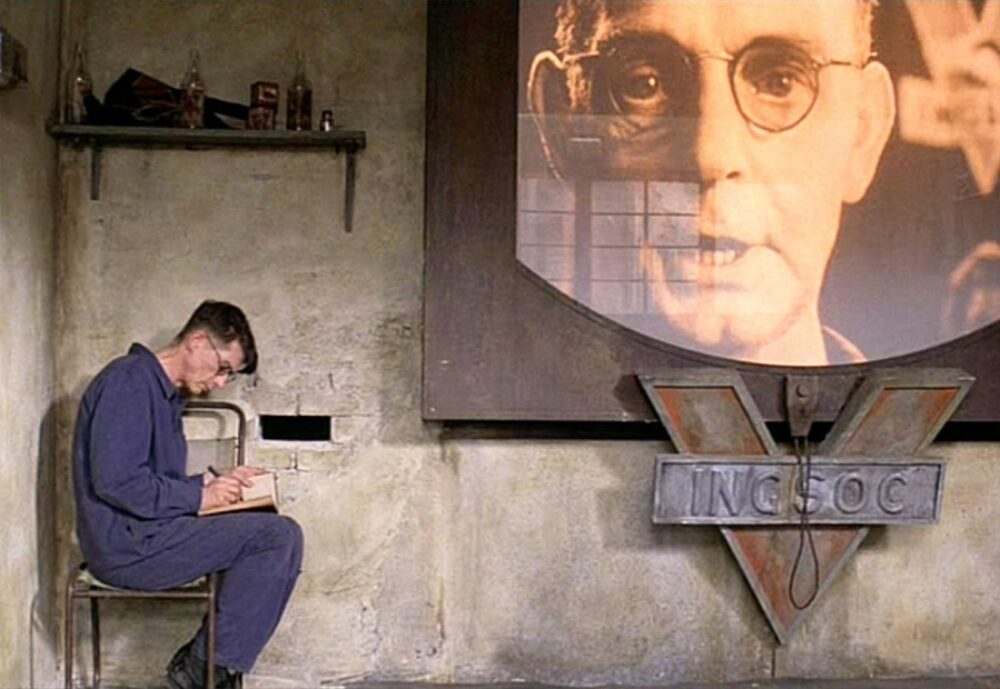Vincenzo, quella macchina, la 500, se l’era comprata con i risparmi di una vita. E già pregustava, mentre firmava tutte le carte che il concessionario gli metteva davanti, una dopo l’altra, lo stupore e l’ammirazione dei vicini di casa. Certo, qualcuno di loro aveva già la Vespa, quella strana motocicletta con le ruote piccole, ma, quasi tutti giravano ancora in bicicletta. La sua, sarebbe stata la prima automobile del quartiere. Quando si ritrovò con le chiavi in mano, si ricordò però di una cosa.
– “Senta, ma è difficile da guidare?”
– “Certamente no! E una macchina come tutte le altre. Da quanto tempo ha la patente?”
– “La patente? Quale patente?”
– “Non ce l’ha?”
Il concessionario, allora spiegò ad un allibito Vincenzo, che per guidare un automobile, non solo quella, tutte le automobili, ci voleva la patente. La patente di guida, appunto. Che non era una cosa che bastava solo chiedere, come una carta di identità, un certificato del Comune. Bisognava fare una scuola, dare degli esami, essere promossi.
La macchina gliela portò a casa uno dei meccanici dell’autosalone. E con una maestria che impressionò Vincenzo, fu parcheggiata dentro il locale che fino a ieri usava per tenere tutte le cianfrusaglie che non trovavano posto altrove. Che, finalmente, era diventato un garage a tutti gli effetti. Rimasto solo, Vincenzo, si sedette dietro al volante. Provò a girarlo, non sembrava molto faticoso, guidare non doveva essere poi così difficile. Quasi senza volere, si ritrovò a borbottare brum brum mentre girava quel volante sempre più rapidamente a destra e a sinistra. Sarebbe stato bello, quando l’avrebbe guidata sul serio, ne era sicuro. Poi, tutte le leve e i pulsanti, questo a cosa servirà? E questo? Il clacson lo spaventò, dentro il piccolo locale risuonò amplificato a dismisura. Ancora, dai! Ancora!
L’autoscuola, quella che gli aveva consigliato il meccanico, era vicina alla fermata dell’autobus. La signora tanto gentile gli aveva chiesto di portare delle fotografie, un certificato medico e altri documenti che lui si era procurato durante la settimana. C’era ancora da pagare la prima rata, pazienza, avrebbe fatto qualche piccola economia. E così, ogni giovedì sera, Vincenzo, insieme ad altri, cominciò ad apprendere il significato dei segnali stradali, il funzionamento del motore, come si dovevano usare gli indicatori di direzione (le frecce, suvvia), quando era necessario accendere i fari. Poi, finita la lezione, prima di salire in casa, faceva qualche esercizio in garage. Si fa così, questo è per accendere luci, questo è il tergicristallo. Apriva il cofano, per cercare le candele, lo spinterogeno, il radiatore. La domenica, invece, armato di spugna e stracci, si dava da fare fino a quando le cromature dei paraurti brillavano come specchi e la carrozzeria lucida, più immacolata di un abito da sposa.
E finalmente venne anche il giorno delle esercitazioni di guida. L’istruttore, dopo avergli dato qualche rapida spiegazione, si sedette accanto a lui e gli fece cenno. Andiamo. Vincenzo girò la chiave e il motore, quello vero, si avviò. Forza, la marcia adesso. La macchina si avviò saltellando, Vincenzo, pallido in volto, girandosi verso l’istruttore cominciò a urlare.
– “Adesso? Che faccio, che faccio?”
– “Stia calmo, guardi avanti, E non si preoccupi, ci sono io”
Calma, calma. Ormai la macchina si era avviata e Vincenzo, abbracciato al volante, non sapeva più che pesci pigliare. Di lato cose che si muovevano, davanti una curva
– “Si calmi, le ripeto. Guardi la curva. Adesso giri il volante piano a sinistra”
– “A sinistra? Dov’è la sinistra. Da che parte?”
E girò a destra, proprio contro il muro. Rumore di lamiere, il cofano divelto, il motore ancora girava. L’istruttore scese, scuro in volto.
– “Direi che per oggi basta, non crede? Forse è meglio che ci rivediamo un altra volta”
– “No. Senta, non l’ho fatto apposta. E’ che davvero…”
– “La prossima volta.”
Vincenzo tornò, abbacchiato, a casa. Scese subito in garage. La sua 500 era sempre lì, ferma, ad aspettarlo.
– “Senti, non è andata molto bene, oggi. Non è che ti offendi se aspettiamo ancora un po’? Tanto qui stai bene. Verrò ogni sera, a farti un po’ di compagnia. Scusami tanto, ma non mi sento ancora pronto.”
E niente, sono passati gli anni, ma Vincenzo, a scuola guida, non c’è più tornato. Ogni giorno scende giù in garage, ormai lo chiama così anche lui, si siede al volante e racconta tutta la sua giornata. Progetta viaggi, studia percorsi. Partiremo presto, sai? Qualche volta si diverte ancora a imitare il rombo del motore, brum brum, dai che la strada è libera. La domenica, ancora, è tutta dedicata alla sua regina. La carrozzeria luccica, i tappetini sembrano nuovi. E, credeteci, si sente l’uomo più felice della terra.