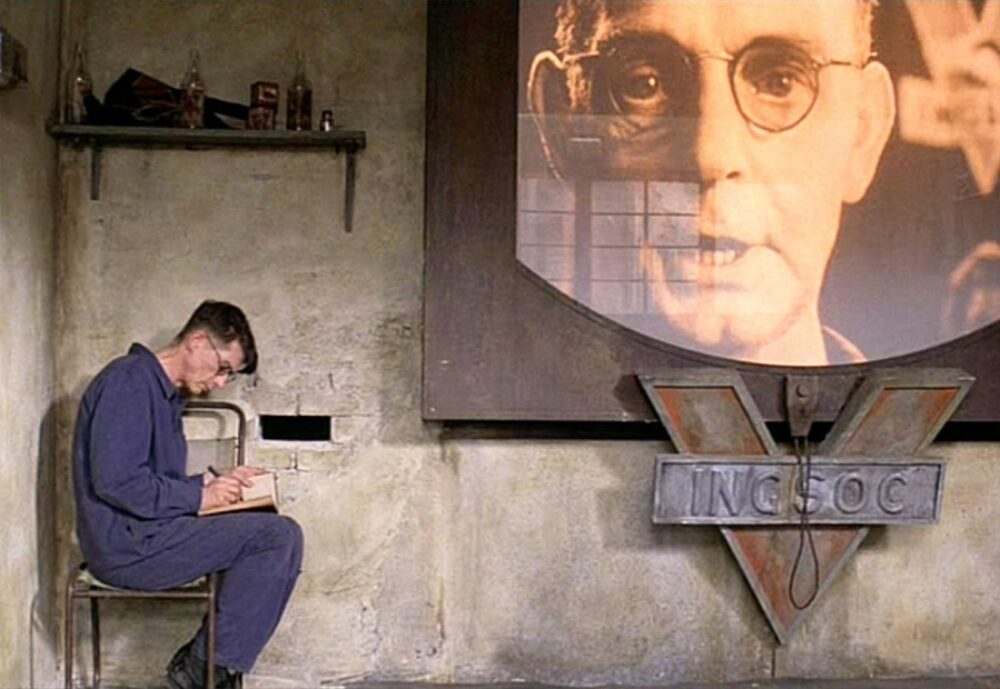Era il novembre del 44, la guerra che sembrava prossima alla fine più di un anno prima, ancora continuava. Con tedeschi che non se ne volevano andare e americani e inglesi che ce la mettevano tutta per farli sloggiare. Il fronte era comunque lontano dal paese, si diceva che gli alleati fossero fermi più a sud, bloccati dietro un fiume. Tutto fermo, insomma. Se non fosse stato per quegli aereoplani che ogni santo giorno venivano a bombardare il ponte della ferrovia, quella che conduceva direttamente al Brennero, quella che i tedeschi usavano per far arrivare rinforzi, cannoni e carri armati, la vita, in paese, sarebbe stata decisamente tranquilla.
Ogni giorno, i bombardieri americani sganciavano tonnellate su tonnellate di bombe su quel piccolo ponte. Piccolo davvero, meno di venti metri a saltare un torrente quasi sempre in secca. Ma era sufficiente colpirlo con almeno uno spezzone, per bloccare tutto il traffico ferroviario verso la Germania. Così, tutte le notti, il plotone di genieri che era accampato in paese, si adoperava per ripararlo in qualche modo. I treni ricominciavano a circolare nelle prime ore del mattino, avanti e indietro. Fino a mezzogiorno, quando le sirene dell’allarme antiaereo ricominciavano a suonare.
Mancavano pochi giorni a Natale, quando uno degli aerei più piccoli, quelli che scortavano i bombardieri con la stella sulla fusoliera, col motore quasi fermo, forse per un guasto, forse colpito da un veicolo tedesco, atterrò nel vigneto del nonno. Strappando fusti e stralci per metri e metri. Il nonno, che si trovava lì per le solite incombenze invernali di ogni contadino che abbia a cuore la sua terra, rimase miracolosamente illeso. Nessuno dei frammenti di metallo staccatisi dall’aereo in quell’atterraggio di fortuna, lo colpì. E passata la paura, pensò bene di sfogare la sua rabbia prendendo a bastonate il pilota, casco di cuoio e giacca con il pelo, che era sbucato fuori dall’abitacolo. Frastornato e arrabbiato quasi quanto lui. Dopo svariate corse tra i vitigni abbattuti, i due, senza più fiato, l’uno di fronte all’altro, avevano cominciato a studiarsi. Il nonno aveva abbassato il bastone, anche perchè si era accorto che l’altro, attaccata alla vita portava una fondina con dentro una grossa pistola. Avevano cercato di scambiare qualche parola, “Io american, americano, tu italiano o german, tedesco?” ” Le mie vigne, mona di un mericano, chi me le paga le vigne?”. E via di questo passo, finché al nonno non era venuta in mente una cosa. Da lì a poco sarebbero arrivati i tedeschi, l’aereo dovevano per forza averlo visto anche loro, atterrare nel campo. E farsi trovare in compagnia di un militare americano non era proprio una buona idea. “Senti, io adesso devo andare, a casa.” “Aiutami, help please, no prisoner, no tedeschi”. Aiutarlo, e come? Non poteva portarselo a casa, se i tedeschi lo venivano a sapere, sul prossimo treno per la Germania avrebbero caricato anche lui. “Per favore, please!” Adesso che la rabbia gli era sbollita, il nonno si era accorto che, una volta tolto casco e occhialoni, quello che aveva davanti era solo un ragazzo spaventato. Senza quel coso di metallo che adesso era piantato, tutto contorto, nel campo, non faceva più paura a nessuno, nemmeno a lui. ” Va bene, andiamo, ma non puoi venire così.” E così lo aveva rivestito con uno dei tabarri che teneva nel capanno degli attrezzi, gli aveva sporcato la faccia e le mani di terra e se l’era tirato dietro. La divisa e tutto il resto dell’armamentario infilati sotto la legna impilata sul carretto. “Spingi, merica. E stai zitto, capito?”
La nonna era quasi svenuta, quando gli aveva raccontato l’accaduto. “Ma sei matto? E dove lo mettiamo questo qui? Ma lo sai che se i tedeschi lo vengono a sapere, ci mettono in prigione tutti quanti?”. “In cantina, lo teniamo in cantina.” E proprio in cantina, tra le botti e i salami appesi, fu alloggiato il mericano. Gli portavano da mangiare due volte al giorno, e facevano a gara, fratelli e sorelle, visto che era facile ricevere in cambio un pezzo di cioccolato o delle gomme da masticare. Parlava tanto il mericano, ma si capiva poco di quello che diceva. I ragazzi si limitavano ad annuire, dopotutto lui li faceva divertire con quelle strane parole e il suo gesticolare. Poi, incassato il premio per il servizio, lo lasciavano di nuovo solo. Ma il giorno di Natale, non si poteva certo lasciarlo solo come un cane, giù, sottoterra. E lo avevano fatto salire, a mangiare con tutta la famiglia il cappone che il nonno aveva ingrassato tutto l’anno. Si erano stupiti, quando era riuscito a rispondere ai loro auguri “Buon Natale, buon Natale”. Anche la nonna, quel giorno, sembrava più tranquilla. La guerra, davvero, sembrava più lontana del solito, e anche i distruttori di ponti, per l’occasione, fecero festa.
Con la seta del paracadute, bello quel tessuto e chi l’aveva mai vista una cosa cosi?, la nonna e la zia avevano confezionato camice e mutande per tutta la famiglia.Dopotutto, senza l’aereo, il mericano non ne aveva più bisogno. Bellissime e comode, quelle camice, peccato non poterle fare vedere a nessuno. Anzi, passate le feste, per quanto povere fossero quelle di quell’anno, bisognava pensare a una soluzione. Certo, ormai era quasi uno di famiglia, anche se abitava in cantina saliva molto spesso a dare una mano in casa, cercava, un po’ alla volta, di imparare l’italiano. Qualche volta, addirittura, il nonno, se l’era portato in campagna a lavorare. Dopotutto, se le vigne erano tutte da ripiantare era colpa sua, che diamine. E poi c’era da smontare quel satanasso di aeroplano ancora lì in mezzo al campo. Con tutta quella lamiera ci si poteva riparare un paio di tetti, di sicuro. Ma erano tutti d’accordo che non poteva restare ancora a lungo con loro. I tranquilli genieri del ponte erano stati raggiunti da un reparto di fanteria della Wehrmacht in riposo dopo mesi passati al fronte. E con questi non si poteva tanto scherzare. Mettevano il naso dappertutto, giravano sempre armati. Qualcosa bisognava fare, per forza. L’idea venne allo zio Giovanni, anche lui soldato, ma nella grande guerra. ” Facile, bisogna mettersi d’accordo coi partigiani.” “I partigiani? E chi li conosce? Chi li ha mai visti?” “Eh, basta dirlo al Griso, lo sanno tutti che lui sta con loro. Persino quelli che stanno dietro al ponte. Ma siccome, grazie a lui, qui non vengono mai a rompere le balle, fanno finta di niente. Piuttosto bisognerà stare attenti a quelli nuovi, hanno certe facce…” Il Griso, avvisato dallo zio, si fece vedere la domenica successiva, dopo messa. Il nonno, dopo aver servito un paio di bicchierini della grappa che, guerra o non guerra, tedeschi o non tedeschi, continuava a distillare di nascosto, fece salire l’americano dalla cantina. “Ah eccolo qui, il mericano ” “Lo sapevi, come…” “Lascia perdere, lo so. Immagino quello che stai per chiedermi. Vuoi che lo restituiamo ai suoi, vero?” “E come si fa?” “Lo faccio venire a prendere da certi amici. Loro lo accompagneranno oltre le linee, che ci vuole? Ti costerà solo qualche bottiglia di vino da dare al sergente degli scavatori. Così, tanto per ringraziamento. Lui l’ha sempre saputo, chi ti tenevi in casa. Si, anche lui.” “Scherzi, vero?” “Ma va, credi davvero che anche loro, come noi, non ne abbiano le scatole piene, di questa guerra? A lui e a tutti i suoi va benissimo così. Finché sono occupati con il loro ponte se ne possono stare tranquilli e aspettare che finisca. Non hanno certo voglia di fastidi. Tipo ufficialetti in cerca di medaglie, capaci di mandarli in giro per tutta la valle, su e giù per le montagne, in cerca dei compagni del tuo americano.” “Ma lui era solo” “Quello lo dici tu. E poi non è detto che a forza di cercare non si trovi davvero qualcuno, magari armato, meglio lasciar perdere. Non conviene a nessuno, a noi e a loro. Comunque va bene, si fa. Ti dirò io, quando”
Vennero a prenderlo un giovedì sera. Faceva molto freddo, era già febbraio. I due venuti ad accompagnarlo portavano il mitra a tracolla e la barba lunga. Ma avevano accettato di buon grado il surrogato di caffè che nonna aveva messo a bollire sopra il fuoco. Erano rimasti un po’ a parlare della guerra con il nonno, mentre i ragazzi osservavano affascinati le armi che i appese insieme ai cappotti. Johnny, il mericano, era nervoso, forse non era del tutto convinto. “Tranquillo, soldatino, ti riporteremo dai tuoi amici. Copriti bene, dovremo attraversare la montagna”. Con lo zaino riempito di pane e salame dalla nonna, i guanti pesanti di lana e il berretto dello zio Giovanni in testa, Johnny il mericano, era partito con loro “Ciao merica, fai attenzione”. Solo un paio di settimane dopo, il Griso, venne a dare notizie. Era andato tutto bene. Il pilota era tornato a casa.
Tag Archives: Natale
Katà Natale
Sono già un paio d’anni che accompagno mia figlia, il martedì e il venerdì, in palestra. Fa karate, la ragazza, non c’è da scherzare con lei. Indossa il suo kimono, si allaccia la cintura e poi via, di corsa sul tatami. Io mi siedo su una panca a lato e guardo. Sono due anni, dicevo, che l’accompagno a queste lezioni, ma, nonostante la lunga osservazione, così come la compagnia di altri genitori di più lungo corso, io continuo a non capirci nulla, di quello che succede su quella specie di stuoia. Sarà perché i ragazzi gridano continuamente, sarà perché ogni volta le evoluzioni sono sempre più complicate. O forse perché ogni gesto, ogni mossa, ogni presa, ha un nome giapponese che io non riuscirei a pronunciare nemmeno sotto tortura. E mentre tutti discutono della lieve imperfezione di un calcio (loro lo chiamano in un altro modo, figuriamoci se riesco a scriverlo), o del ritardo infinitesimale di una difesa, io annuisco, sorrido, butto lì un “bene bene”. Però, anche quando la ragazza si dedicava ad uno sport meno esotico, la pallavolo, non sono mai riuscito a penetrare i profondi misteri delle regole di quel gioco. Che gli altri accompagnatori, invece, padroneggiavano benissimo. Mi piaceva veder giocare, questo sì, ma mai mi sarei azzardato a discutere su una palla fuori o su un presunto tocco della rete. Evidentemente ho un blocco funzionale per tutti gli sport, escluso il ciclismo, naturalmente. Per il quale, non pago di saper sciorinare termini tipo finisseur, sprinter, en danseuse, pistard, non mi lascio scappare nessuna occasione di pontificare ovunque mi trovi. Al bar come in treno. Ve lo dico io, chi vince il Giro, quest’anno.
Stasera, comunque, ci sono più spettatori del solito, in palestra. C’è l’esame di cintura. Che, naturalmente, è un rito di passaggio, si accede a livelli e misteri più elevati. Il maestro, anzi il Maestro, stasera è più Maestro del solito. Che non solo di tecnica è fatto il karate, ma sopratutto di spirito, ci tiene a sottolineare. E adesso lo vedremo. Schiacciato tra la folla dei genitori competenti, osservo le prove, gli esercizi. Sono i kata, dei susseguirsi di attacchi e difese, che vanno eseguiti alla perfezione. A dir la verità, a me, più che forme sembrano simboli. Nel senso che se l’avversario non c’è, è puramente immaginario, anche il combattimento è simbolo, spirito appunto. Ma al maestro, al Maestro, non gliel’ho mai detto. Dopotutto non ci capisco niente e lui è cintura nera con non so quanti dan, metti che si arrabbia? La mia ragazza è brava, però, gli esercizi, i kata, li fa tutti bene. Anche tutta la giuria è d’accordo, vorrei ben vedere. Li fa da sola, prima. Poi insieme agli altri ragazzi, sembra quasi un balletto di Stravinsky, il Petruskha o la Sagra della Primavera. Applausi, applausi, è finita. Le cinture vengono consegnate, a mia figlia tocca quella verde. Prevedo già la richiesta di un McDonald per concludere la serata. Certo, lo spirito e importante. Ma è anche piuttosto golosa la ragazza. Il papà, intimorito da tutti quei calci e pugni virtuali, dovrà per forza dire di sì. E poi è quasi Natale, siamo tutti più buoni. Il Maestro congeda tutti, ci racconta una storia. Su come ognuno debba trovare la sua via, l’illuminazione, il Do. Naturalmente il karate, spiega, serve proprio a questo. Rammento che una volta gli ho spiegato come la mia di illuminazione, l’ho trovata pedalando in un pomeriggio d’agosto, sull’Izoard. Mi ha guardato un po’ stranito, non capiva. Ma dopotutto io sono un mukyu, un senza cintura. Questo l’ho imparato.
Anna che vola via
Anna, l’avevamo lasciata alle prese con la pizza surgelata per i ragazzi e il trucco da sistemare. Per un venerdì sera da passare fuori con le amiche e un pretendente non ancora dichiarato. Ma, almeno a detta di tutte, bloccato solo dalla timidezza, perché innamorato lo è di sicuro. Per evidenti motivi di riservatezza non racconteremo nulla, di quella serata. Siete liberi di immaginare quel che volete: sguardi d’intesa, frasi più o meno rivelatrici, magari persino un bacio. Oppure la solita partita a scacchi, il bianco muove, il nero difende, subito arrocco. Ma è stato comunque qualche mese fa, l’anno era appena cominciato. Non deve essere accaduto nulla di importante, visto che i giorni sono trascorsi, per Anna, sempre allo stesso modo. Il lavoro, i figli, tutte le cose da fare e tutte quelle per cui non c’è mai tempo. E’ arrivata la primavera e poi l’estate. Le gonne si sono accorciate e poi si sono allungate nuovamente. Silvano, così si chiamava il timido partito caldeggiato dalle amiche, si è certamente defilato. Ma non sembra che lei lo rimpianga. Gli indecisi non gli sono mai piaciuti, gli ricordano troppo qualcuno in particolare. La sera meglio a casa presto, qualche carezza al gatto, un po’ di TV e chiacchiere virtuali. E’ diventata più forte, però, questo lo sa. Il tempo, senza parere, qualcosa ha portato. Questo Natale sarà diverso dagli altri, che se ne sono andati lasciandosi dietro solo recriminazioni e piccole rivalse. Anche la città, alla quale in fondo non si è mai abituata, le sembra diversa, questa volta. Le luci colorate, gli alberi nelle piazze, non ricordano più cose tristi, è davvero cambiato qualcosa dentro di lei. E forse è pronta per una storia nuova, una vera, da cercare da sola. Senza tanti suggerimenti. Senza tanta claque intorno. Forse già stasera, dopo la cena della vigilia, gli auguri. Lo stesso trucco dell’altra volta, un vestito nuovo. Sono sempre io, ma ho cose nuove da dire. Si ricomincia da capo e, stavolta ne è sicura, fra i tanti regali, le sorprese, ce ne sarà una anche per lei.
Al parco
Del resto, quando proprio sotto la panchina ho trovato il portafogli, ho pensato che i soldi me li potevo pure tenere. Non è che sono dieci milioni, sono cento euro scarsi, poca roba. Me li bevo stasera, ci esce anche da mangiare. Una pizza, qualche panino. Carina la ragazza, però, guarda la foto. Capelli lunghi, un bel sorriso. Che dice la carta d’identità? Abita qui vicino, solo un paio di vie più in là. Magari l’ho anche vista, qualche volta. Viene qui a fare jogging, ci scommetto. In tuta e scarpette. Rosse e blu. I capelli se li lega dietro, così non le danno fastidio. E corre avanti e indietro su questi sentieri. No, sono sicuro, non ha un cane che l’accompagna, non è il tipo. Un gatto, piuttosto, le piacciono i gatti. Ne ha almeno due, a casa. Che l’aspettano mentre lei è al lavoro. O quando viene qui, al parco. Ha anche un fidanzato, un ragazzo, è ovvio. Bello pure lui, coi soldi, mica uno come me. Lui è po’ geloso dei suoi gatti, ma non glielo dice. Quando la va a trovare le porta sempre un regalino, dei fiori, magari una scatola di cioccolatini. Lei è contenta, mangiano insieme in cucina, lei è una brava cuoca, e poi lui si ferma da lei a dormire. Prima o poi si sposeranno e faranno anche dei bambini. Li cresceranno, li manderanno a scuola Ogni anno, la notte di Natale, metteranno tanti pacchetti sotto l’albero. Li scarteranno insieme, la mattina. Saranno felici, tutti i giorni. E non avranno freddo, non avranno mai freddo.
Il paltò che mi hanno dato i ragazzi della parrocchia è troppo leggero, non basta. Mi ci vorrebbe del vino, mi scalderebbe, mi farebbe bene. Ma al supermercato non mi fanno più entrare. Il direttore, quella volta che mi ha visto chiedere la mancia per riportare i carrelli, si è arrabbiato tanto. E ha detto che se mi facevo rivedere ancora, chiamava la polizia. E io con i poliziotti non sono mai andato d’accordo. Anche quando sono gentili e mi offrono qualcosa da mangiare. Il fatto è che poi mi vogliono portare all’ospedale, dicono sempre che lì starei meglio, almeno per un po’. Voglio proprio andarla a vedere, la casa della ragazza. Sono solo due passi e io non ho niente da fare. Ah, è quel palazzo nuovo, hanno finito di tirarlo su giusto l’anno scorso. Tutto colorato, con i balconi grandi e l’ascensore tutto di vetro. E qui che abita lei. Fammi vedere i campanelli: no, no, ecco. Quinto piano. Quasi quasi potrei riportarle il portafogli, ma il portiere, di sicuro, non mi farà entrare. Peccato, mi piacerebbe vederlo, il suo appartamento. E anche i suoi gatti. Magari mi offrirebbe anche un caffè. Eh già, proprio a uno come me. Non sognare, dai. Sono sporco, puzzo. Non mi ricordo nemmeno come mi chiamo, da dove vengo, io. Però, posso mettere il portafogli nella sua cassetta delle lettere. Così non dovrà rifare tutti i documenti. Penserà che l’ha trovato qualche vicino di casa. Uno come lei, con la foto bella sui documenti. Lascio anche i cento euro, dentro il portafogli. Ci comprerà un regalo di Natale. Per i suoi bambini.
Il Ciula
Giacomino, “il Ciula”, non se lo ricordava nemmeno più, da quanto stava dentro. Trent’anni? Di più? Non faceva comunque differenza, se prima c’era stata un’altra vita, era svanita quando era entrato in carcere. E non gli mancava, non ci pensava mai, tanto si era abituato alla routine di celle e cortili, punizioni e ore d’aria. Nemmeno il motivo, sapeva più raccontare ai nuovi che, ogni giorno, incontrava sui lunghi corridoi chiusi a intervalli regolari da sbarre di ferro chiuse a chiave ogni sera.
Ne aveva conosciuta tanta di gente, tanti ne aveva visti entrare e uscire. Qualcuno anche di molto famoso, con il nome sempre sui giornali. Come il bel Renato, che gli regalava spesso pacchetti interi di sigarette, quando lo mandava a portare qualche ambasciata, in cortile, a uomini che tutti gli altri detenuti evitavano accuratamente. Perché il minimo sgarbo, la minima offesa la si sarebbe pagata davvero cara. Ma il Ciula, con la sua timidezza, con il suo italiano traballante, era amico di tutti. E gli si perdonava tutto. Come quella volta che in mensa era inciampato e aveva rovesciato il vassoio con la minestra proprio sulle scarpe del maresciallo. Tutti i suoi compagni di cella lo avevano difeso dalle ire del graduato, organizzando anche una colletta per l’acquisto di un nuovo paio di calzature.
Anche il Direttore lo lo aveva preso in simpatia. Incuriosito da quell’uomo mite e sempre sorridente, aveva studiato tutti gli incartamenti, ricostruito tutto il peregrinare del Ciula per i carceri d’Italia. Controllato note e pareri di chi l’aveva preceduto. L’aveva convocato più volte nel suo ufficio, una domanda di grazia, che diamine, davvero non vogliamo prepararla? Giacomino, il Direttore lo chiamava sempre per nome, si era sempre schermito. Uscire per fare cosa? Io non saprei cosa fare, dove andare. Qui ho degli amici, un posto, un lavoro da fare tutti i giorni. Sto bene così. In effetti, il Cappellano che diceva messa ogni domenica giù nel salone grande, aveva confermato tutto quanto. Il Ciula, davvero non aveva nessuno, fuori dalle mura. Padre e madre erano morti da anni, dei fratelli e delle sorelle si era persa traccia. L’unico che si era riusciti a trovare, su al nord, dove aveva messo in piedi una piccola impresa edile, aveva categoricamente negato qualsiasi aiuto. Se esce, io non ne voglio sapere nulla, da quel giorno là non è più mio fratello. A nulla erano valse le esortazioni del sacerdote
Il Ciula, quando glielo avevano raccontato, non se l’era presa. Fa bene, aveva detto, ed era tornato a pulire il corridoio davanti alla sua cella. Sono stato cattivo con loro e questo è quello che mi merito. Il Direttore aveva lasciato perdere e la vita di Giacomino era continuata così. La sveglia alla mattina, il caffè portato dalle guardie, muoviti Ciula che si fa tardi, la passeggiata in cortile, le lunghe partite a carte.
Giacomino, ci aiuti a fare il presepe, quest’anno? Glielo aveva chiesto il prete, quello del colloquio con il fratello. Sai, credo che ti piacerà. Lo sai chi è Gesù Bambino, vero? E anche tutti gli altri personaggi del presepe. Questa è Maria, questo è Giuseppe, i pastori, i re magi… Il Ciula aveva cominciato a disporre le statuine, sul tappeto verde, mentre il prete raccontava la storia di un uomo e di una donna che non avevano trovato posto nell’albergo. Si erano rifugiati dentro una grotta. Ad attendere la nascita di un figlio. E mentre ascoltava queste parole, di colpo, si era ricordato. Di un altro Natale, della neve fuori dalla finestra, di un presepe uguale a questo. Del profumo dei dolci, delle canzoni cantate nei vicoli, di un’altra famiglia. Padre, devo andare a casa! Ed era corso lungo i tutti i corridoi, davanti allo sguardo stupito di tutte le guardie. Devo andare, mi aspettano! E’ Natale! Davanti all’ultimo cancello, quello sempre chiuso a tripla mandata, dovette fermarsi. Non poteva andare oltre. Aprite, dai! Devo andare, sono in ritardo! E quando il maresciallo, con le sue scarpe nuove, gli pose delicatamente un braccio sulla spalla, per riaccompagnarlo in cella, vieni Giacomino, per la prima volta si sentì davvero in prigione.
Buon Natale
Io arrivo per Natale, ma non ho la barba bianca. E nemmeno un vestito rosso. Io arrivo per Natale, ma mica ho una slitta, delle renne, i campanelli. Anzi, non ho mai visto la neve. Non so cos’è. Qui fa sempre caldo. Io arrivo su una barca. Piena fino all’inverosimile. Di gente come me. Che non ha voglia di far festa, che ha lasciato indietro tutto il suo passato, che ha lasciato indietro tutto quanto. Io arrivo, nonostante le onde e il vento. Ho speso tutto, per questo viaggio, non più niente in tasca. Ho baciato mia moglie e i miei figli, salutato mio padre e mia madre. E sono partito. Il capitano di questa piccola nave, segue una stella, lui dice che ci porterà a destinazione. Come è successo per altri, tanti e tanti anni fa . Veniamo dall’est e dal sud, io e tutti quelli insieme a me. Non siamo re, non siamo magi. Ma siamo in viaggio. E non sappiamo se stiamo portando quello che aspettate voi. Che, in questo momento, state comprando gli ultimi regali. Voi, che siete in fila per pagare, che aspettate chi incarta i vostri pacchetti. Noi siamo in viaggio, ancora ve lo ricordo. Io con gli altri. Arrivo per Natale ma conosco a malapena il vostro dio. Ma spero sia migliore del mio, che non ha saputo aiutarmi. Che non ha levato fame e malattie ai miei figli, che non mi ha concesso di guadagnarmi il cibo di cui abbiamo bisogno ogni giorno. Ma so che per onorarlo, il vostro dio, vi radunate sotto un albero, oppure attorno a ad un immagine che rappresenta, con piccole statue di asini, buoi, pastori, la sua nascita. E pregate affinché ci sia pace per tutti. Ecco, io sono nato in un posto dove gli alberi non crescono, dove buoi, asini, pastori, non sono solo semplici immagini, ma la realtà. La realtà di ogni giorno. Non sono il vostro Messia, non sono quello destinato a salvarvi. Ma, per favore, sto arrivando, non cacciatemi via.
La buona novella
Il sole stava tramontando rapidamente, tingendo di rosso le rovine dove la carovana aveva deciso di accamparsi per la notte. I cammelli carichi di spezie e stoffe pregiate avevano ben presto trovato rifugio tra le mute macerie di una civiltà che ormai tutti avevano dimenticato. Salah, il capocarovana, conosceva quel luogo fin da bambino. Quante volte vi aveva fatto tappa nei suoi numerosi viaggi! Ma anche lui ignorava il nome dell’antica città, chi l’avesse costruita, perché fosse stata, infine, abbandonata. Diede in fretta gli ordini necessari affinché fossero accesi i fuochi, cucinato il cibo, montate le tende. Fra poco sarebbe calata l’oscurità e il caldo afoso del giorno avrebbe lasciato posto al gelo della notte. Ordinò anche che ai limiti dell’accampamento fossero disposte delle sentinelle. Qualche volta, infatti, aveva dovuto difendere se stesso e quello che trasportava dai predoni del deserto. Di una in particolare, portava ancora i segni nella lunga cicatrice che segnava una delle sue guance. Ma era stato tanto tempo fa, quando la via delle carovane era stata tracciata, quando il cammino che portava al mare era ancora giovane. Ma la prudenza è una virtù sempre apprezzabile, soprattutto in un capo. Salah osservò con orgoglio i suoi uomini, che, vicino ai fuochi, si godevano il meritato riposo. Mai aveva avuto compagni di viaggio così forti e risoluti, poteva stare tranquillo. Fu proprio mentre discuteva con alcuni di loro il cammino che li attendeva per l’indomani che risuonò il grido di allarme di una sentinella. Salah accorse subito e osservò il deserto nella direzione indicata dal braccio della vedetta. Tre uomini si stavano avvicinando, velocemente, all’accampamento. Erano ancora troppo lontani per distinguere se fossero armati o meno, ma la loro meta era, senza dubbio, l’antica città. Salah fece cenno ai suoi compagni di attendere, tre uomini, viandanti o predoni che fossero, non avrebbero certo costituito un pericolo, per una carovana grande come la sua. Quando furono più vicini, Salah e i suoi poterono notare come i tre uomini fossero legati tra loro da una lunga fune. Il primo era avvolto in un mantello blu che non riusciva a nascondere un fisico imponente, da lottatore, forse. Apriva con maestosità il cammino agli altri due, che ne seguivano i passi quasi con circospezione. Dietro di lui, con un mantello rosso, un uomo magrissimo, il viso del colore più scuro che il capo carovana avesse mai visto. “Deve essere uno di quelli che chiamano mori”, pensò Salah. L’ultimo della fila, vestito di nero, era certamente il più dimesso. Piccolo e tarchiato, la lunga barba bianca, sembrava inciampare ad ogni passo. Il trio si fermò a pochi passi da Salah e i suoi uomini, che si erano disposti intorno al loro capo, pronti a sguainare, se necessario, le loro sciabole. Fu l’ultimo della fila a a parlare, quello vestito di nero.
-”Chiediamo ospitalità per questa notte”
-”Chi siete?” Rispose Salah
-”Siamo solo tre viandanti. Non abbiamo armi e veniamo in pace, cerchiamo solo un posto per riposare”
-”Perché procedete legati l’uno all’altro? Dove state andando?”
-”Il luogo dove siamo diretti è un mistero anche per noi. Sappiamo solo che dobbiamo rivolgere i nostri passi verso le terre del tramonto. In quanto al perché procediamo in questo modo, avrò modo di spiegartelo più tardi, se vorrai accoglierci al tuo bivacco.”
-”Venite dunque in pace, scaldatevi al nostro fuoco e saziatevi col nostro cibo”
-”Dio saprà ricompensarti.”
I tre allora si fecero avanti, verso il centro dell’accampamento, sempre con il gigante vestito di rosso ad aprire il cammino, Salah li fece accomodare nella sua tenda e ordinò venisse portato loro cibo e acqua. Mangiarono in silenzio, lentamente, mentre il capo carovana ne studiava i gesti, le espressioni del viso. Terminato il pasto, Salah interrogò ancora i tre.
-”Ora mi racconterete di voi e del vostro strano modo di viaggiare?”
Fu ancora il piccolo uomo vestito di nero a parlare.
-”Certo. Ma quello che vogliamo raccontare, non è solo per te, ma anche per tutti gli uomini che ti accompagnano. Usciamo e radunali tutti”
Salah diede gli ordini necessari. Presto tutti gli uomini della carovana si disposero attorno ai tre. Quando anche l’ultimo di loro ebbe preso posto, il moro e il colosso si posero alla destra e alla sinistra del barbuto vestito di nero. E questi cominciò a parlare.
-”Non è la fune che vedete, l’unica cosa che ci tiene legati l’uno all’altro. Quello che ci tiene veramente avvinti è la storia che vi racconteremo. Ma permettete, innanzitutto, che io presenti i miei compagni di viaggio.
Quello vestito di blu è Melkor, le cui potenti braccia sanno piegare il ferro. Egli vive in silenzio, mai le sue labbra hanno proferito un suono. Nemmeno quando è venuto al mondo. L’uomo dal mantello rosso e dalla pelle d’ebano è, invece, Gasphar. A differenza di Melkor possiede il dono della favella, ma per lui il mondo è immerso nello stesso silenzio che i nostri sapienti sostengono esistere nell’infinito spazio vuoto e freddo che circonda le stelle. Io, infine, sono Balthasar, e vivo da sempre nell’oscurità. Di mia madre ho solo conosciuto la voce e le carezze, della mia terra solo i profumi e il calore del sole. La storia che stiamo per raccontare non è avvenuta nel mondo reale, che voi tutti conoscete, ma solo dentro la mia testa. Io ne ho immaginato l’inizio, gli avvenimenti, il finale. L’ho narrata a Melkor, che, con segni, gesti, sguardi, l’ha ripetuta a Gasphar. Che, dopo averla appresa, l’ha recitata nel silenzio che gli è eterno compagno. Così è ritornata alla mia testa. E non era cambiata. Ho pensato allora che questa storia era davvero speciale, che sarebbe rimasta la stessa anche quando fosse stata raccontata in tutte le lingue che dividono gli uomini fin dal tempo di Babele. Una storia che poteva unire, finalmente, quello che allora era stato diviso. Ma quando questa storia ha preso forma nella mia mente, io non conoscevo ancora i miei compagni che, come me, vengono dalle terre dove il sole sembra sorgere ogni mattino. Vedete, prima di cominciare questo viaggio, io professavo l?arte della poesia alla corte di un grande re. Cantavo le sue gesta, osannavo la sua potenza militare, riempivo di lodi la sua benevolenza. Con che facilità le mie labbra proferivano rime eleganti e raffinate! Ma non potevo dettare questa storia, così come dettavo le mie strofe, al mio giovane scriba… Sentivo dentro di me che avrei dovuto consegnarla la mondo in un altro modo, che non era destinata ai ricchi cortigiani che affollavano la reggia del mio signore, ma a tutte le genti che non trovavano posto in quel ricco palazzo. Così, un mattino, ho lasciato i miei comodi appartamenti e mi sono messo in cammino, portando con me solo una bisaccia con un po’ di pane e un bastone.”
Baltashar interruppe il suo racconto per bere dall’otre che Melkor, con estrema delicatezza, aveva accostato alle sue labbra. Salah ne approfittò per parlare, interrompendo con un cenno i mormorii tra i fuochi.
-”Io ho sentito parlare di te. Un mercante di Esfahan mi raccontò, molto tempo fa, di un famoso poeta, il prediletto di un grande re, scomparso dalla sua corte, senza lasciare traccia. Eri tu, quindi. Ma dove volevi andare? E come? Tu, perdonami, cieco, solo. Non avevi paura?”
-”Sì, ma non potevo fare altrimenti. Dovevo andare. Del resto, appena fuori dalle mura, ho incontrato Melkor, o forse sarebbe meglio dire che gli sono andato a sbattere contro. Lui non ha protestato, non ha imprecato contro di me. Chi era? Stava arrivando o, proprio come me, stava abbandonando la città? Non rispondeva. Ho provato ad interrogarlo ancora, ho usato tutte le lingue che conoscevo, lingue apprese da principi e ambasciatori di ogni parte del mondo. Niente. Solo quando ho sentito le sue mani sfiorarmi prima il capo e poi le labbra, ho compreso che non poteva rispondermi. Ma sentiva la mia voce, avevo forse trovato il primo ascoltatore per la mia storia. Gli ho chiesto se voleva seguirmi, se voleva venire con me, se voleva, anzi ,farmi da guida, anche se non sapevo, dopotutto, dove stavo andando. Lui ha afferrato la mia mano, l’ha stretta forte, ha accettato. Quella stessa notte, seduti accanto al fuoco che Melkor aveva acceso, ho raccontato la storia che fra poco potrete udire anche voi. Io narravo e Melkor, stringendo le mie mani nelle sue, ascoltava. L’alba ci ha sorpresi proprio quando il racconto volgeva al termine. Quello che ormai ritenevo il mio unico e ultimo compito aveva avuto inizio. Siamo partiti seguendo l corso del sole, così avevo chiesto a Melkor, perché, pur se non sapevo nulla della nostra destinazione, di dove avremmo dovuto andare, una strana convinzione si era impadronita di me. Quella era la direzione giusta, verso il tramonto, il resto sarebbe venuto da sé. Affinché potessimo marciare con speditezza, senza che io restassi indietro, o peggio, mi perdessi, egli mi ha legato a sè con una fune. Abbiamo così camminato per giorni e giorni. E, ogni notte, io ripetevo la mia storia, non volevo dimenticarla. Una sera, proprio mentre stavamo cercando un posto adatto per passare la notte, ho udito una voce dietro di noi. Subito mi sono arrestato, chi lanciava quel richiamo? Melkor, che camminava davanti a me, naturalmente, non ha udito nulla e ha strattonato al corda che ci teneva legati. Solo dopo qualche minuto sono riuscito a fermarlo, ponendomi davanti a lui, a fargli capire che stava succedendo qualcosa.”
-”Era Gasphar, vero?”, interruppe Salah.
-”Era Gasphar. Quando finalmente ci ha raggiunti ho riconosciuto la lingua della mia terra d’origine. Ci chiedeva chi eravamo, dove stavamo andando. Ho presentato me e Melkor. Ho raccontato del nostro viaggio, ma in cambio ho ricevuto, ancora, le stesse domande. Ho allora ripetuto le mia parole una, due, più volte. Ancora niente. Poi Melkor ha toccato con delicatezza le mie orecchie ed io ho capito. Gasphar non poteva udirmi, era sordo. LA sorte mi aveva dato un altro compagno con cui non potevo intendermi. Poi, superato lo scoramento, mi sono ricordato di quello che avevo sentito raccontare, tanto tempo prima, a palazzo, da dei viaggiatori stranieri. Sostenevano come uomini privati della favella o dell’udito potessero comunicare fra loro usando segni e gesti. Ho chiesto allora a Melkor se lui conoscesse quel particolare idioma. Mi ha risposto Gasphar, lo conoscevano tutti e due, potevano intendersi. Più tardi, dopo esserci preparati per la notte, grazie all’aiuto del nuovo compagno, ho potuto conoscere finalmente il nome di Melkor, che fino a quale momento ignoravo. Così come ho potuto conoscere il suo passato. Certamente la sua mole, i suoi muscoli, che avevo toccato più volte, mi avevano fatto pensare ad un uomo di grande forza, ma non potevo certo immaginare come egli fosse uno schiavo fuggito dalla dimora del suo padrone. Troppi anni aveva passato a far girare la pala di un pozzo, troppi compagni aveva visto morire, annientati dalla fatica. Quando il destino ci aveva fatti incontrare, la sua fuga, al pari della mia, era appena incominciata. Di sé, invece, Gasphar mi raccontò come egli fosse un astrologo al servizio, come me, di un potente sovrano. Il suo regno si trova aldilà di Multan e Dalbul, i suoi sudditi sono soliti chiamarlo Moghul. Mi raccontò anche di come avesse intuito, dopo l’apparizione di una strana stella mobile, che attraversando il cielo lasciava dietro di sé una scia di fuoco, che avrebbe dovuto mettersi in cammino verso occidente. Alla ricerca di chi cosa egli ancora non sapeva, ma, ne era certo, ci sarebbero stati altri segni, altri presagi. Dopo le sue spiegazioni, ho raccontato nuovamente la storia generata dalla mia fantasia e ho atteso che Melkor la traducesse, con segni e gesti, ha Gasphar. Così è stato. E, finalmente, ho potuto riascoltarla da una voce diversa dalla mia. La storia, l’ho già affermato, non era cambiata. Le parole che Gasphar pronunciava erano le stesse che erano uscite, qualche minuto prima, dalle mie labbra. Era una magia? Era un altro segno, un altro presagio, diceva Gasphar. Che cosa dovevamo fare, allora? Raccontala ancora, certo, raccontarla a tutti, non potevamo fare altro. Ecco perché siamo qui, allora, ecco perché ora racconteremo questa storia anche a voi. Perché proprio per questo, ne siamo certi, il destino a voluto che noi tre ci incontrassimo.”
Salah e i suoi uomini avevano ascoltato in silenzio l’ultima parte del racconto di Balthasar. I fuochi, che nessuno aveva provveduto ad attizzare si erano ormai spenti e, nel buio, la voce del viandante cieco sembrava provenire dalle rovine che circondavano l’accampamento. Salah si alzò in piedi e diede ordini affinché qualcuno provvedesse alla legna da ardere. Poi si rivolse a Balthasar:
-”Cè una cosa che forse ancora ignori. Forse, come dici tu, un altro segno. La mia carovana, nel lungo viaggio verso occidente, sta seguendo, come guida, la stessa stella di cui tu ci hai parlato. La stella che lascia dietro di sé una lunga scia di fuoco.
-”Si tratta davvero di un altro segno. Vedi? Il nostro cammino doveva incrociare il tuo.”
-”Allora racconta la tua storia, Balthasar, noi ti ascolteremo, perché questo, ne sono convinto, è ciò che vuole il cielo.”
Alle luce dei fuochi ormai ravvivati, i tre viandanti si alzarono in piedi, Balthasar ,dopo sussurrato qualcosa all’orecchio Melkor, tornò a sedersi. Così fece anche Melkor dopo aver scambiato qualche segno con Gasphar. Toccava a lui narrare, quella notte. E Gasphar, dopo aver ancora scrutato il cielo, alla ricerca della sua stella, iniziò a narrare.
-”Io non racconterò la storia di un re. Io racconterò la storia di un uomo. Ecco come avvenne la sua nascita: sua madre, Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe…..”
Ma tu vulive ‘a pizza
Due, dicesi due mozzarelle giù nel carrello. La passata di pomodoro, anzi la polpa, che così viene più buona. E poi l’impasto per pizza, che farlo in casa, con la macchinetta tedesca che sforna panini, marmellate, impasti vari, meglio se costituiti da farine integrali di cereali fra i più disparati, è noioso. Tocca pulire, poi. Ma il rito della pizza della domenica sera è qualcosa di irrinunciabile, non solo contravverrebbe alle norme che, da più di dieci anni, regolano il funzionamento di questa famiglia. Ma, ne sono certo, potrebbe scatenare l’ira di svariati Lari. Ira che solo il sacrificio sull’altare domestico, del gatto di casa, potrebbe calmare. E allora, di fronte al frigorifero inspiegabilmente privo dei necessari ingredienti, non mi resta altra soluzione che raggiungere il più vicino supermercato. Aperto, come ormai si conviene, anche in ogni festività religiosa e laica del calendario. Dieci minuti e faccio tutto, mi dico, in realtà non è una propria e vera adesione al consumismo più spinto, quello che ti vorrebbe alla cassa di un centro commerciale qualsiasi a tutte le ore di tutti i giorni dell’anno. E solo la riparazione ad una piccola dimenticanza, anzi, un caso di emergenza. Ma la vera dimenticanza, sono davvero sbadato, è che cominciato, non ci avevo proprio fatto caso, lo sprint, ogni anno si parte sempre da più lontano, verso il Natale. Parcheggio strapieno, naturalmente, la macchina la devo lasciare molto più in là, giusto dietro un segnale di divieto. Mi pare proprio di sosta. Pazienza, poi si vede. Entro e subito rischio di venire investito da qualche carrello spinto con fin troppa energia. Zigzagando fra le corsie, nonni, padri, nipoti, cugini di primo e secondo grado si agitano un po’ dappertutto, prendo quelle tre cose, anzi quattro, che pure la birra è finita, e mi metto in coda. A Panama. Sì, perché l’impressione è quella di essersi infilati in un convoglio di bastimenti che attendono ognuno il loro turno per attraversare il canale. Carrelli riempiti fino all’inverosimile di merci varie, anche esotiche, ma soprattutto in sconto. E’ ovvio che mi rassegno subito, qui passerò del tempo, il “il torno fra dieci minuti”, si è già dilatato a mezz’ora e la fila e ancora lunga. E per non annoiarmi, dopo qualche tentativo di trovare interessanti gli aggiornamenti sulla mia pagina FB, comincio a sbirciare nei carrelli altrui. Biscotti, tanti biscotti, tutti comperano tonnellate di biscotti. O raccogliendo i punti puoi vincere una serata con Banderas, e allora si spiega lo sguardo corrucciato di molti mariti e l’aria invece giuliva delle consorti, oppure a casa aspettano torme di ragazzini in attesa della colazione. Bottiglie, bottiglie, bottiglie di acque minerali di ogni tipo e capacità. Giuro, persino una marca belga, probabilmente imbottigliata da frati trappisti che hanno deciso di smetterla con l’alcool. E surgelati: sofficini, arancini, involtini, spiedini e stuzzichini. Ma non mancano cozze, gamberi e cape sante. Spigole, sogliole, persino del pesce spada. I più intellettuali sfoggiano, invece, confezioni di sushi e sashimi, sarà un natale non convenzionale, il loro. E con il tre per due, anche abbondante. L’ananas, i datteri, i fichi secchi da appendere all’albero, cioccolatini in scatole grandi quasi come gli imballaggi dell’Ikea. Salse e condimenti da tutti gli angoli della Galassia, frutta fuori stagione. Zamponi, cotechini, salmone affumicato d’oltremanica. Mancano all’appello, stranamente, panettoni e pandoro. Quelli li si compra la vigilia, ovvio, che te li danno al 50%. E’ il mio turno, la cassiera mi guarda con aria stranita, non riesce a comprendere le ridotte dimensioni del mio cargo, infilato quasi di contrabbando fra quelle petroliere. Pago tutto con monete metalliche, giusto per rafforzare la sua idea che, appena uscito, andrò a chiedere l’elemosina fuori da un altro centro commerciale. Non mi dà nemmeno il bollino a cui avrei diritto, tanto è sicura che lo rivenderei. In macchina, mentre torno a casa, è già passata un ora e mezza, mi coglie un pensiero orrendo. Ho dimenticato di comprare il prosciutto.