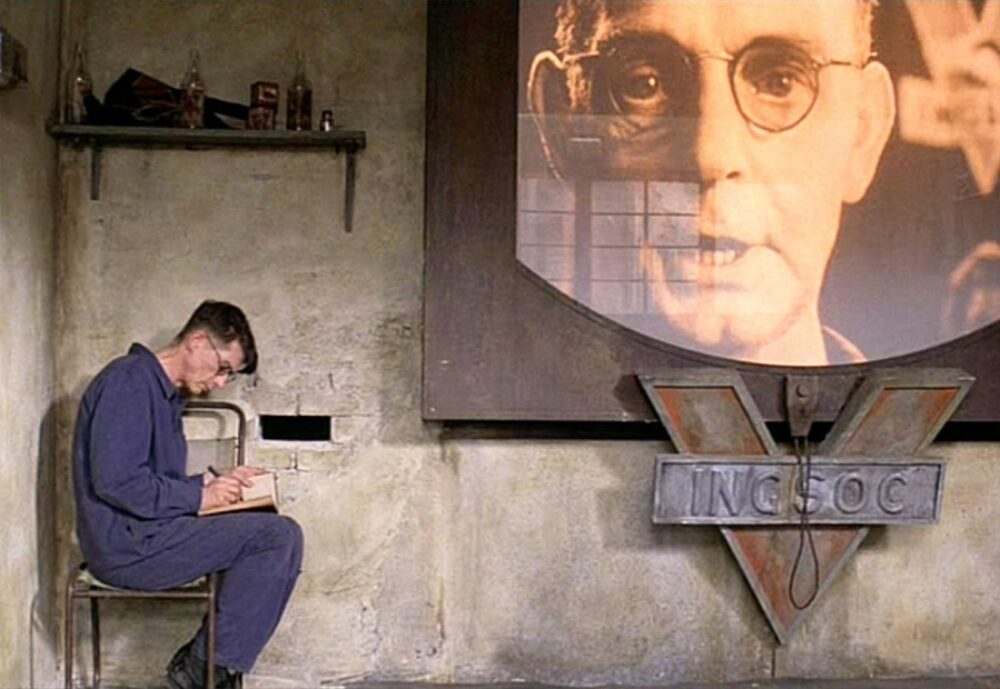Quando la fabbrica aveva chiuso, giusto pochi giorni prima di Natale, era terminato anche il periodo di cassa integrazione. Quasi un anno avanti e indietro da uno stabilimento che ormai produceva solo per forza d’inerzia. Marzo al lavoro, aprile a casa, maggio si vedrà. E poi settembre, fino a quando i cancelli si erano chiusi definitivamente, le catene di montaggio, da dove uscivano quei bolidi rombanti destinati a rimanere invenduti, si erano fermate. Erano arrivate le lettere con le solite frasi: “Siamo spiacenti, ma la situazione di mercato non ci consente di…”, gli ultimi soldi. A poco erano serviti i picchetti, le bandiere rosse, gli slogan urlati sotto i palazzi di Comune e Provincia, non si poteva fare più nulla. Anche il famoso investitore straniero aveva ritirato le sue offerte, quelle su cui tutti i più anziani, prossimi alla pensione, avevano riposto le loro speranze. Che si fa adesso?
Se anche i sindacati alla fine si erano arresi, la stampa non aveva invece mollato la presa. Quello stabilimento, quella fabbrica chiusa, faceva parte della storia della città. E le auto costruite da quegli uomini in tuta blu, avevano contribuito al prestigio di una città che da sempre ambiva ad essere la prima d’Italia. In tutto. Anche in quel campo che sembrava appannaggio esclusivo dell’altra città, che proprio delle automobili si dichiarava la capitale. E su questo, ma soprattutto sul destino di quegli operai, continuava a sfornare colonne su colonne, denunce su denunce. Bisognava pensare a quegli uomini, alle loro famiglie, qualcuno doveva trovare una soluzione. E ci pensò il governo, naturalmente, che, un poco in difficoltà ad elezioni ormai prossime, non poteva farsi sfuggire l’occasione di recuperare consensi. Le imprese di stato, ecco la soluzione. Quelle imprese che contavano così tanti dipendenti da rendere quasi impossibile un conteggio degli stessi. Di certo non avrebbero avuto difficoltà ad assorbire quelle poche centinaia di disoccupati. Gente abituata a lavorare, tra l’altro. E non era cosa da poco. Qualcuno alle Ferrovie, allora, qualcuno alle Poste, ecc.
A Paolo erano capitate le Poste e la cosa non gli era dispiaciuta. In ferrovia, si sa, si è sempre in viaggio, lontani da casa. E la divisa, visto che doveva fare il portalettere gliela avrebbero data lo stesso. Paolo infatti non aveva fatto il militare, era terzo fratello e quindi dispensato, non averla mai indossata, una divisa, gli era sempre bruciato un po’. Come erano belli, i suoi fratelli, quando venivano a casa in licenza. Adesso si sarebbe levato la voglia. Quando lo avevano chiamato a firmare per l’assunzione però, a febbraio, aveva avuto una piccola delusione. Portalettere, certo, ma non a Milano, lì erano già al completo, purtroppo. Bisognava scegliere qualche località fuori porta, dove i postini invece scarseggiavano. Starai anche meglio, gli dissero, nei paesi la gente è più cordiale, non ha tante pretese, come qui in città. Ecco qui l’elenco, scegli.
San Giuliano, allora, che ci si arriva col pullman che parte da Corso Lodi. Bisogna alzarsi presto, però, che alle sette devi essere lì, in ufficio. Due stanzoni enormi, riscaldati a malapena dai grandi termosifoni in ghisa. Le pareti bianche e scaffali strapieni di lettere e pacchi. “ Sei arrivato finalmente! Io sono Vito, tu sei Paolo, vero?” Il capoufficio lo aveva accolto con benevolenza, erano mesi che aspettava qualcuno per smaltire tutto quel lavoro arretrato. Bollette ormai scadute, auguri per il Natale passato, giornali con notizie della settimana scorsa. “Ti dò la zona a nord, quella delle cascine. Dovrai pedalare un po’, a proposito la tua bici è quella lì, ma vedrai che ti troverai bene. E’ brava gente, un bicchiere di vino ci scappa sempre. E se arrivi per ora di pranzo…” Paolo si era schermito, ma no, non è il caso. Piuttosto, come avrebbe fatto a trovarle, quelle case in piena campagna? Lui veniva da Milano che ne sapeva? “Tranquillo, i primi giorni lavorerai con Attilio, lui ti farà vedere e ti insegnerà tutto quello che devi sapere”. E così era andata. Attilio, ormai agli ultimi mesi di servizio, aveva accompagnato il suo successore per quella periferia non ancora urbanizzata. Cascine, piccole officine, ma soprattutto campagne attraversate da piccole strade da poco asfaltate. Qui ci stanno i Callegari, brava gente loro. Più in là i Bettini e i Meregalli. Paolo cercava di ricordarsi tutto: le strade, i cognomi, le case, i bivi. Salutava, apriva la borsa e faceva firmare la raccomandata. Buona giornata signora. Arrivederci.
Quel giorno, il suo primo giorno da solo, era arrivato in ritardo. Il pullman, in quella nebbia che si sarebbe potuta tagliare a fette come il salame, avanzava a fatica. Vito, comunque, l’aveva accolto con un sorriso:” Capita spesso qui, non ti preoccupare. Piuttosto, stai attento con la bicicletta, ci vuole un attimo a finire in un fosso. E l’acqua è fredda” Paolo aveva riempito la borsa ed era partito subito inghiottito dalla nebbia. Nebbia che attutiva anche il rumore della vecchia bicicletta, tanto che Paolo, per non sentirsi troppo sperduto, aveva sentito il bisogno di cantare. A San Giuliano, in ufficio, la giornata era trascorsa lenta. Pochi clienti, quasi nessuno era uscito di casa, con quel tempo. Due tre vaglia, un pacco, qualche francobollo. A mezzogiorno, Vito e Attilio, tutti e due con la schiscetta preparata dalla moglie, non si erano stupiti più di tanto del ritardo di Paolo “Con questa nebbia ci metterà di più a finire il giro. E poi lo sai come sono fatti, se per caso è passato dai Callegari, di sicuro l’hanno invitato a pranzo”. Solo tardo pomeriggio, si erano fatte le quattro, fra un ora avrebbe fatto buio, avevano cominciato a preoccuparsi. “Non gli sarà mica successo qualcosa? Oggi è da solo e non si vede a due metri, vuoi vedere che si è perso?”
Vito aveva allora tirato fuori la sua seicento e lui e Attilio erano partiti alla ricerca di Giorgio. L’uno al volante, l’altro con la testa fuori dal finestrino per cercare d vedere oltre la coltre di nebbia. Erano passati dai Ceruti, dai Carrera, dagli Oggioni. Niente. Nessuno l’aveva visto, da lì non era passato. Costeggiato tutto il fosso dei Carminati, hai visto mai che ci fosse caduto dentro. L’osteria dei Santambrogio, la cascina dei Mainardi. E poi dai Besana, la casa più lontana, l’ultima del suo giro. Niente nemmeno lì. Vito e Attilio, ormai disperati, avevano proseguito lungo la strada, i fari inutilmente accesi, per chilometri e chilometri. Cristo, dove era finito, Paolo? Era sera, ormai, quando l’avevano trovato. A Caselle Lurani, ormai alle porte di Lodi. Seduto su un paracarro, la bici abbandonata a terra con la borsa ancora piena, Paolo, tutto solo, piangeva.