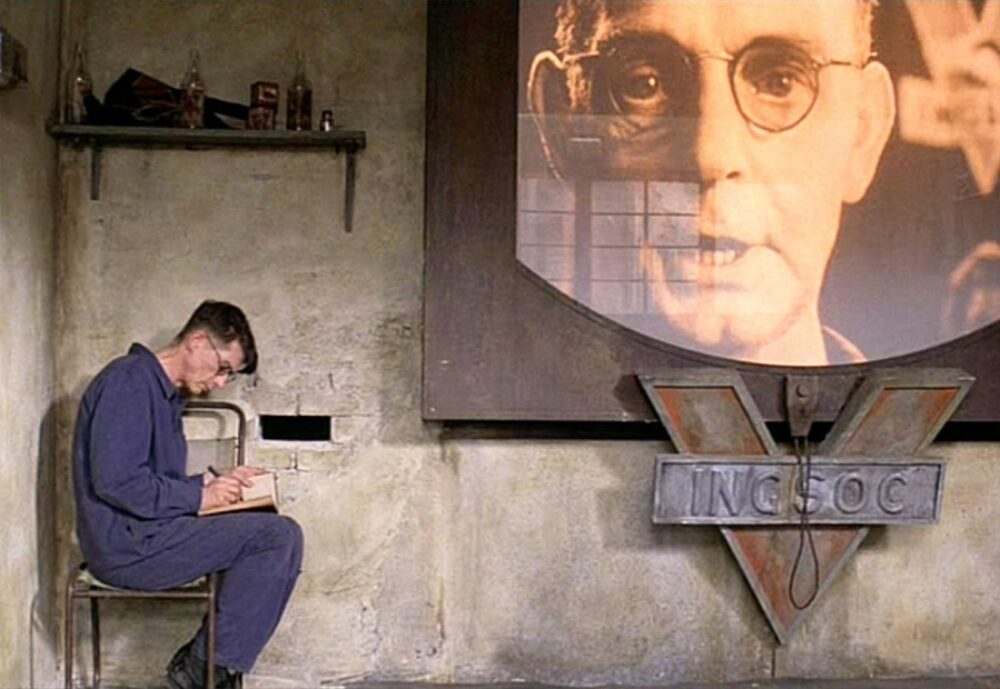Era il novembre del 44, la guerra che sembrava prossima alla fine più di un anno prima, ancora continuava. Con tedeschi che non se ne volevano andare e americani e inglesi che ce la mettevano tutta per farli sloggiare. Il fronte era comunque lontano dal paese, si diceva che gli alleati fossero fermi più a sud, bloccati dietro un fiume. Tutto fermo, insomma. Se non fosse stato per quegli aereoplani che ogni santo giorno venivano a bombardare il ponte della ferrovia, quella che conduceva direttamente al Brennero, quella che i tedeschi usavano per far arrivare rinforzi, cannoni e carri armati, la vita, in paese, sarebbe stata decisamente tranquilla.
Ogni giorno, i bombardieri americani sganciavano tonnellate su tonnellate di bombe su quel piccolo ponte. Piccolo davvero, meno di venti metri a saltare un torrente quasi sempre in secca. Ma era sufficiente colpirlo con almeno uno spezzone, per bloccare tutto il traffico ferroviario verso la Germania. Così, tutte le notti, il plotone di genieri che era accampato in paese, si adoperava per ripararlo in qualche modo. I treni ricominciavano a circolare nelle prime ore del mattino, avanti e indietro. Fino a mezzogiorno, quando le sirene dell’allarme antiaereo ricominciavano a suonare.
Mancavano pochi giorni a Natale, quando uno degli aerei più piccoli, quelli che scortavano i bombardieri con la stella sulla fusoliera, col motore quasi fermo, forse per un guasto, forse colpito da un veicolo tedesco, atterrò nel vigneto del nonno. Strappando fusti e stralci per metri e metri. Il nonno, che si trovava lì per le solite incombenze invernali di ogni contadino che abbia a cuore la sua terra, rimase miracolosamente illeso. Nessuno dei frammenti di metallo staccatisi dall’aereo in quell’atterraggio di fortuna, lo colpì. E passata la paura, pensò bene di sfogare la sua rabbia prendendo a bastonate il pilota, casco di cuoio e giacca con il pelo, che era sbucato fuori dall’abitacolo. Frastornato e arrabbiato quasi quanto lui. Dopo svariate corse tra i vitigni abbattuti, i due, senza più fiato, l’uno di fronte all’altro, avevano cominciato a studiarsi. Il nonno aveva abbassato il bastone, anche perchè si era accorto che l’altro, attaccata alla vita portava una fondina con dentro una grossa pistola. Avevano cercato di scambiare qualche parola, “Io american, americano, tu italiano o german, tedesco?” ” Le mie vigne, mona di un mericano, chi me le paga le vigne?”. E via di questo passo, finché al nonno non era venuta in mente una cosa. Da lì a poco sarebbero arrivati i tedeschi, l’aereo dovevano per forza averlo visto anche loro, atterrare nel campo. E farsi trovare in compagnia di un militare americano non era proprio una buona idea. “Senti, io adesso devo andare, a casa.” “Aiutami, help please, no prisoner, no tedeschi”. Aiutarlo, e come? Non poteva portarselo a casa, se i tedeschi lo venivano a sapere, sul prossimo treno per la Germania avrebbero caricato anche lui. “Per favore, please!” Adesso che la rabbia gli era sbollita, il nonno si era accorto che, una volta tolto casco e occhialoni, quello che aveva davanti era solo un ragazzo spaventato. Senza quel coso di metallo che adesso era piantato, tutto contorto, nel campo, non faceva più paura a nessuno, nemmeno a lui. ” Va bene, andiamo, ma non puoi venire così.” E così lo aveva rivestito con uno dei tabarri che teneva nel capanno degli attrezzi, gli aveva sporcato la faccia e le mani di terra e se l’era tirato dietro. La divisa e tutto il resto dell’armamentario infilati sotto la legna impilata sul carretto. “Spingi, merica. E stai zitto, capito?”
La nonna era quasi svenuta, quando gli aveva raccontato l’accaduto. “Ma sei matto? E dove lo mettiamo questo qui? Ma lo sai che se i tedeschi lo vengono a sapere, ci mettono in prigione tutti quanti?”. “In cantina, lo teniamo in cantina.” E proprio in cantina, tra le botti e i salami appesi, fu alloggiato il mericano. Gli portavano da mangiare due volte al giorno, e facevano a gara, fratelli e sorelle, visto che era facile ricevere in cambio un pezzo di cioccolato o delle gomme da masticare. Parlava tanto il mericano, ma si capiva poco di quello che diceva. I ragazzi si limitavano ad annuire, dopotutto lui li faceva divertire con quelle strane parole e il suo gesticolare. Poi, incassato il premio per il servizio, lo lasciavano di nuovo solo. Ma il giorno di Natale, non si poteva certo lasciarlo solo come un cane, giù, sottoterra. E lo avevano fatto salire, a mangiare con tutta la famiglia il cappone che il nonno aveva ingrassato tutto l’anno. Si erano stupiti, quando era riuscito a rispondere ai loro auguri “Buon Natale, buon Natale”. Anche la nonna, quel giorno, sembrava più tranquilla. La guerra, davvero, sembrava più lontana del solito, e anche i distruttori di ponti, per l’occasione, fecero festa.
Con la seta del paracadute, bello quel tessuto e chi l’aveva mai vista una cosa cosi?, la nonna e la zia avevano confezionato camice e mutande per tutta la famiglia.Dopotutto, senza l’aereo, il mericano non ne aveva più bisogno. Bellissime e comode, quelle camice, peccato non poterle fare vedere a nessuno. Anzi, passate le feste, per quanto povere fossero quelle di quell’anno, bisognava pensare a una soluzione. Certo, ormai era quasi uno di famiglia, anche se abitava in cantina saliva molto spesso a dare una mano in casa, cercava, un po’ alla volta, di imparare l’italiano. Qualche volta, addirittura, il nonno, se l’era portato in campagna a lavorare. Dopotutto, se le vigne erano tutte da ripiantare era colpa sua, che diamine. E poi c’era da smontare quel satanasso di aeroplano ancora lì in mezzo al campo. Con tutta quella lamiera ci si poteva riparare un paio di tetti, di sicuro. Ma erano tutti d’accordo che non poteva restare ancora a lungo con loro. I tranquilli genieri del ponte erano stati raggiunti da un reparto di fanteria della Wehrmacht in riposo dopo mesi passati al fronte. E con questi non si poteva tanto scherzare. Mettevano il naso dappertutto, giravano sempre armati. Qualcosa bisognava fare, per forza. L’idea venne allo zio Giovanni, anche lui soldato, ma nella grande guerra. ” Facile, bisogna mettersi d’accordo coi partigiani.” “I partigiani? E chi li conosce? Chi li ha mai visti?” “Eh, basta dirlo al Griso, lo sanno tutti che lui sta con loro. Persino quelli che stanno dietro al ponte. Ma siccome, grazie a lui, qui non vengono mai a rompere le balle, fanno finta di niente. Piuttosto bisognerà stare attenti a quelli nuovi, hanno certe facce…” Il Griso, avvisato dallo zio, si fece vedere la domenica successiva, dopo messa. Il nonno, dopo aver servito un paio di bicchierini della grappa che, guerra o non guerra, tedeschi o non tedeschi, continuava a distillare di nascosto, fece salire l’americano dalla cantina. “Ah eccolo qui, il mericano ” “Lo sapevi, come…” “Lascia perdere, lo so. Immagino quello che stai per chiedermi. Vuoi che lo restituiamo ai suoi, vero?” “E come si fa?” “Lo faccio venire a prendere da certi amici. Loro lo accompagneranno oltre le linee, che ci vuole? Ti costerà solo qualche bottiglia di vino da dare al sergente degli scavatori. Così, tanto per ringraziamento. Lui l’ha sempre saputo, chi ti tenevi in casa. Si, anche lui.” “Scherzi, vero?” “Ma va, credi davvero che anche loro, come noi, non ne abbiano le scatole piene, di questa guerra? A lui e a tutti i suoi va benissimo così. Finché sono occupati con il loro ponte se ne possono stare tranquilli e aspettare che finisca. Non hanno certo voglia di fastidi. Tipo ufficialetti in cerca di medaglie, capaci di mandarli in giro per tutta la valle, su e giù per le montagne, in cerca dei compagni del tuo americano.” “Ma lui era solo” “Quello lo dici tu. E poi non è detto che a forza di cercare non si trovi davvero qualcuno, magari armato, meglio lasciar perdere. Non conviene a nessuno, a noi e a loro. Comunque va bene, si fa. Ti dirò io, quando”
Vennero a prenderlo un giovedì sera. Faceva molto freddo, era già febbraio. I due venuti ad accompagnarlo portavano il mitra a tracolla e la barba lunga. Ma avevano accettato di buon grado il surrogato di caffè che nonna aveva messo a bollire sopra il fuoco. Erano rimasti un po’ a parlare della guerra con il nonno, mentre i ragazzi osservavano affascinati le armi che i appese insieme ai cappotti. Johnny, il mericano, era nervoso, forse non era del tutto convinto. “Tranquillo, soldatino, ti riporteremo dai tuoi amici. Copriti bene, dovremo attraversare la montagna”. Con lo zaino riempito di pane e salame dalla nonna, i guanti pesanti di lana e il berretto dello zio Giovanni in testa, Johnny il mericano, era partito con loro “Ciao merica, fai attenzione”. Solo un paio di settimane dopo, il Griso, venne a dare notizie. Era andato tutto bene. Il pilota era tornato a casa.